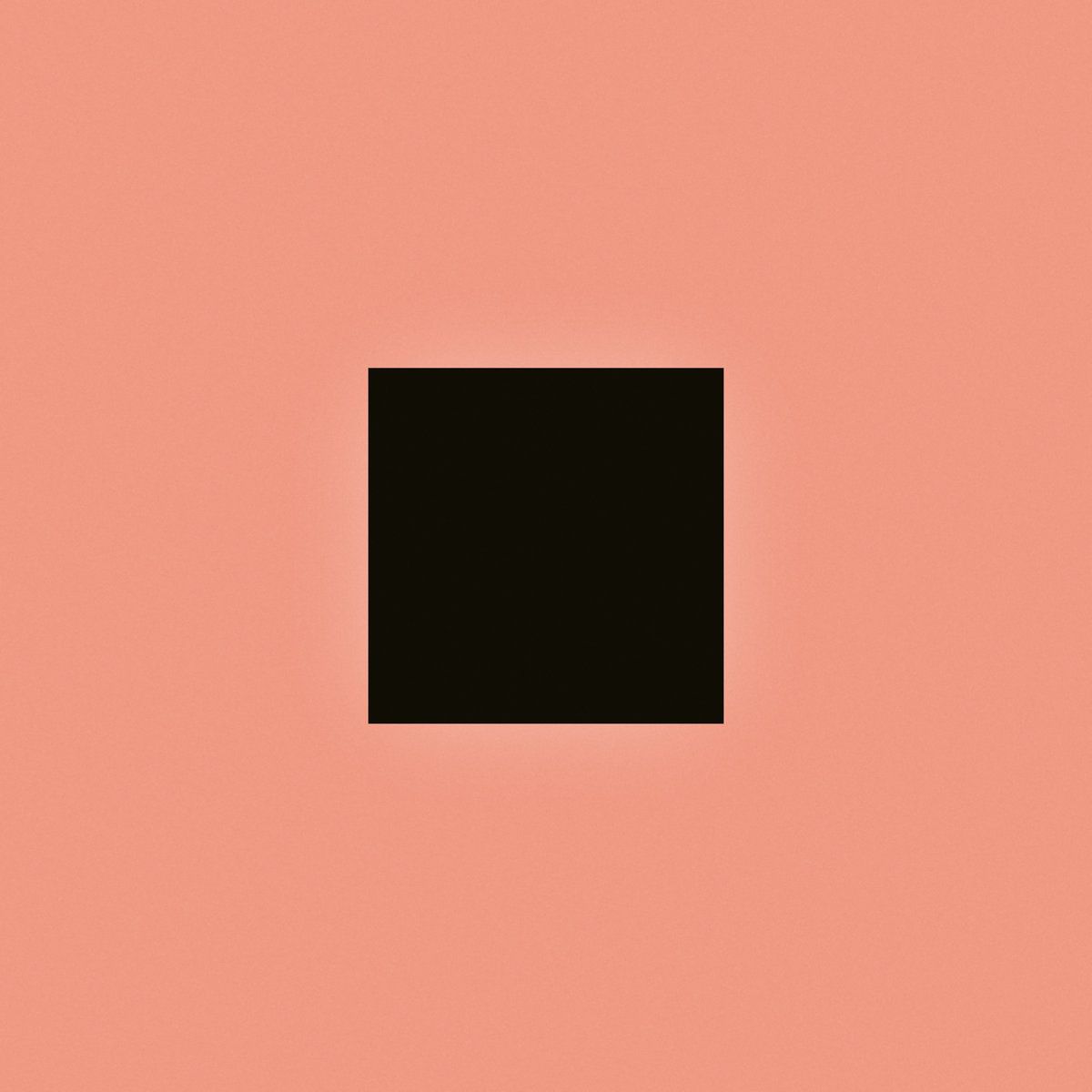SABLE, fABLE
I Bon Iver ritornano. Ma come tornano?
Sono passati quasi vent’anni da quando Justin Vernon si è chiuso nel capanno da caccia del padre nel freddo Wisconsin, con il cuore spezzato, per autoprodurre un album malinconico, dolcissimo e perfetto come For Emma, Forever Ago (2008).
Dopodichè il moniker Bon Iver diventò la definizione di un sentimento, di una vibe, di una ricetta che personalmente ancora rispetto alla lettera: i Bon Iver si ascoltano soprattutto in autunno e in inverno, preferibilmente con ferite da sanare. Il caldo anelito della voce di Vernon deve avvolgere e sciogliere i ghiacci dell’anima, come un bivacco gentile.
Ad oggi è doveroso osservare che il folk intimista delle origini non è rimasto immutato (giustamente): l’indie pop si è fuso con il soul e con l’elettronica, esercizi di stile, collaborazioni scintillanti con Kanye West, Taylor Swift o James Blake. A tratti è parso che il collettivo virasse in maniera decisa verso un mainstream marcato, altre volte che desse priorità alla ricerca, al puro gusto di sperimentare, senza sottintendere un chiaro disegno alla base del proprio operato, come nel caso di i,i (2019), forse il loro album meno compreso.
In questo senso, SABLE, fABLE si inserisce come prodotto risolutivo delle tendenze che hanno caratterizzato la discografia pregressa. L’album esordisce con i tre brani usciti nell’EP pubblicato ad ottobre 2024, SABLE, ovvero THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS, S P E Y S I D E e AWARDS SEASON. Costituiscono un prologo, una prima stagione in cui il dolore viene elaborato, digerito, con i toni nostalgici, crepuscolari che tipicamente associamo ai Bon Iver.
In AWARDS SEASON, che si può considerare una sorta di manifesto dell’album, la voce rimane l’unico elemento sonoro in un corridoio pressoché silenzioso, in cui di tanto in tanto fa capolino un pianoforte, l’eco di una chitarra lontana, un coro che armonizza poche frasi e un sax che lascia spazio alla coda finale a cappella. Qui Vernon afferma: “But I’m a sable and honey, us the fable”, comunicandoci e anticipandoci uno dei temi dell’album, ossia il confronto con un partner, l’intenzione di completarsi, superando gli ostacoli del quotidiano.
Con Short Story sentiamo il vento cambiare direzione, sta sbocciando fABLE, (anche questa vede la produzione di Jim-E Stack): si passa dal minore al maggiore, compare una voce femminile che già introduce il tema dello sdoppiamento, si passa da uno a due. In Everything Is Peaceful Love, primo singolo pubblicato a San Valentino, Vernon non canta l’amore come una vertigine, ma come una condizione di quiete e di scelta quotidiana. Una delle tinte stilistiche più forti è data dal soul che inonda questa produzione come forse mai prima d’ora, in particolare nel trittico Everything Is Peaceful Love, Walk Home e I’ll Be There: ifraseggi in falsetto di Vernon abbracciano i cori dal calore quasi gospel, sostenuti da impalcature di synth, tastiere effettate, pedal steel e percussioni elettroniche. Esce leggermente dalla categoria From, che nel chorus ci riporta al pop anni ’90.
È però in If Only I Could Wait, il duetto con Danielle Haim, scritto durante una reclusione creativa agli April Base, che si tocca uno dei vertici emotivi dell’album. Le due voci si rincorrono e si aprono a spiraglio su una confessione comune: non sempre riusciamo a essere la versione migliore di noi stessi. Vernon non giudica, non idealizza: osserva. Anche qui anziché frammentare la voce con distorsioni e manipolazioni sonore, come nei lavori precedenti, la espone nella sua nuda fragilità.
È con questa nuova prospettiva, questa fragile luce, che si giunge alle tracce finali. There’s A Rhythmn è la traccia più lunga dell’album, 5:16, dopo AWARDS SEASON, 5:17, e definisce questo procedere con passo misurato, gentile, nei giorni, nelle settimane e nelle vite degli altri. Una melodia che si ripete come una regola. L’outro strumentale, sospeso e incantevole, di Au Revoir sembra avere proprio lo scopo di abitarla questa regola.
Non siamo più nei boschi innevati del Wisconsin, né nel caos numerologico di 22, A Million (2016). Siamo in una casa costruita a due, forse ancora in bilico, ma abitata. Ogni canzone è una stanza che si può attraversare con passo lento, magari tenendo la mano di qualcuno. Vernon firma così un album che è tanto un congedo quanto un nuovo inizio e, come ogni favola che si rispetti, lascia addosso una strana speranza: che il dolore possa diventare memoria, e la memoria sia la traccia che conduce in un bel posto.