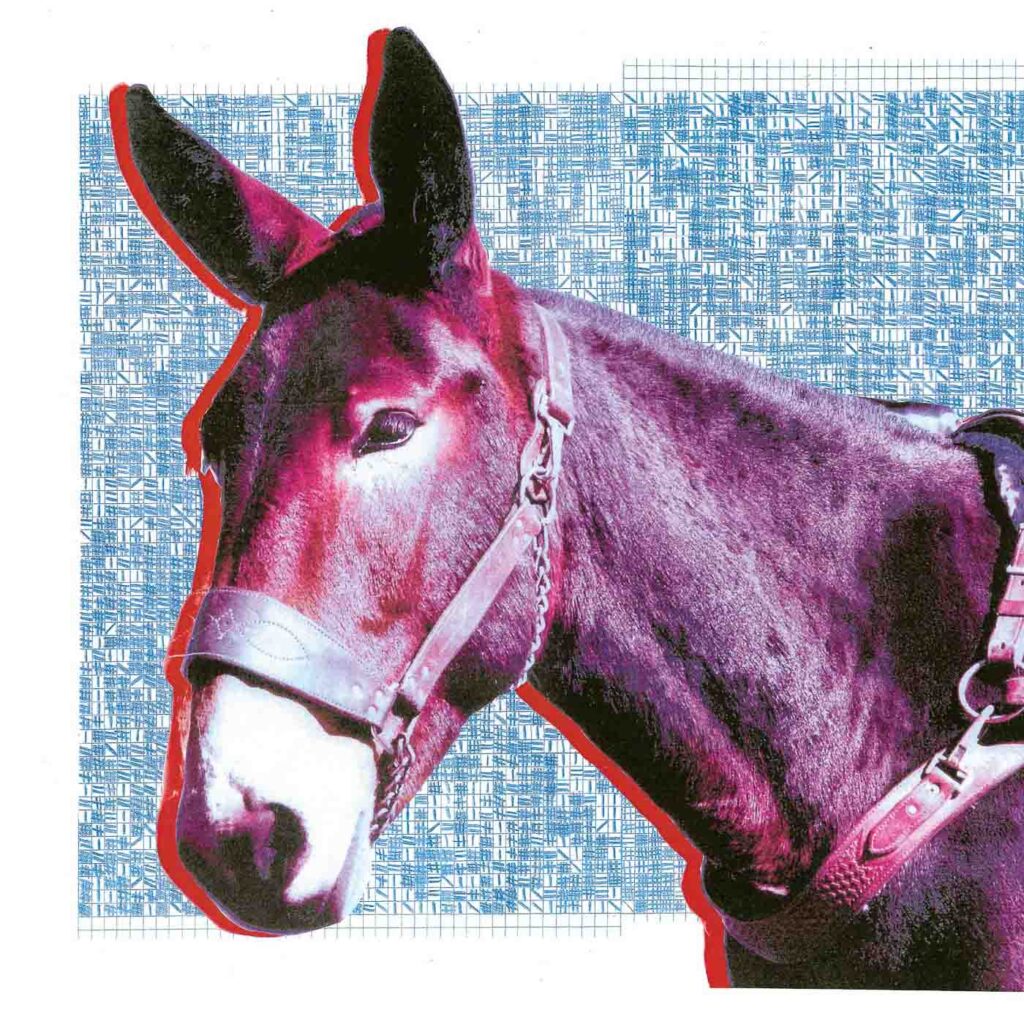Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Imola) // 5 Luglio 2020
• Il concerto che non c’è •
Scena 1
Torino, esterno, giorno.
Inside Job
Il giorno prima di ogni concerto, soprattutto se dei Pearl Jam, corro.
Cuffie nelle orecchie e corro. Lascio che la loro musica entri in circolo con la respirazione, seguo il ritmo, mandando all’aria ogni buon consiglio sulla corsa. Visto da fuori sembrerò pazzo, più che un allenamento è riallineamento, una overdose di musica propedeutica una razione doppia di endorfine.
Ma è liberatorio, col sudore se ne vanno pensieri inutili e preoccupazioni, cerco di tornare alla neutralità, pronto all’urto del concerto.
Correre, quasi un lusso. Appartengo a quella schiera di runner cui è stato impedito di sudare in pubblico. Non è stato un sacrificio, non credo di aver fatto la mia parte rinunciando a così poco. Però mi mancava.
Guardo le gambe, sento la destra che perde colpi, usurata da pallavolo e calcio.
Guardo davanti e sorrido, perché ogni volta, più o meno verso lo stesso albero (sarà l’ossigenazione del cervello che salta sempre allo stesso chilometro), mi suggerisco la solita, facile metafora della corsa come allegoria della vita. Inizio, sudore, fine. Superamento costante dei propri limiti. Un passo dopo l’altro. E giù di cliché a pioggia, un ibrido tra Moccia e i perugina. E se Moccia fosse un ghost writer dei messaggi dei baci? E se avesse iniziato così?
Inizia a piovere.
Corro e scarto pensieri. Corro e costruisco storie che vorrei fermare, vorrei scrivere, ma sono liquide, come liquido sto diventando io. Come stai Andrea? Come arrivi a questo concerto?
Eddie mi ricorda proprio adesso che “how I choose to feel is how I am”. Le parole delle canzoni, mentre il tuo cuore pompa sangue e I tuoi muscoli iniziano a lamentarsi entrano come coltelli nel burro e non fanno a tempo a depositarsi che subito provocano catene di associazioni, è come stare su un tapis roulant al Louvre. Rimangono impressioni, torneranno su più tardi, coll’acido lattico.
Corro col solo obbiettivo di costringere il corpo a cercare il letto prima della mente. Stanco, devo essere stanco. Stasera non penserò a domani, o subentrerà l’ansia da prestazione, per me e per loro.
Cazzo quanto piove.
Oddio, arriva.
Let me run into the rain
To be a human light again
Dissolvenza in nero.
Inside Job.
Scena 2
Interno auto, autostrada, giorno.
Light Years
I viaggi in auto verso i concerti sono come le prime pagine dei libri. Hai curiosità e diffidenza verso qualche faccia nuova, o magari sei felice come un bambino, perché ritrovi personaggi lasciati lì, chiusi dopo l’ultima pagina dell’ultimo concerto.
Si parla di qualunque argomento, l’importante è che dalle casse esca musica che vada bene a tutti.
La dimensione del viaggio ci era stata negata, e mai come ora capisco quanto sia importante mettere chilometri tra il proprio divano e un qualcosa che accade altrove.
Chilometri, parole, musica, un’autostrada che si riempie sempre più di automobili piene di nostri simili, diretti verso lo stesso luogo, stessi sorrisi, stesse colonne sonore, magari stesse storie.
Dalle casse riconosco Light Years, e la domanda è sempre la stessa: le canzoni capitano casualmente nei momenti giusti o sono i pensieri che seguono segretamente le note e ti ritrovi a pensare se le canzoni capitino casualmente.
Al Pinkpop Festival del 2000 Eddie Vedder dedicò questa canzone all’amica Diane Muus, scomparsa tre anni prima, a trentatré anni. Eddie così parlò: “sometimes you have got friends that don’t fuck up at all and are great people. And then you just lose them for some reason. They are off the planet and you never had a chance to say goodbye. I only mention this because there was a person we used to know here and that was Diane and ah, we never got a chance to say goodbye. This is goodbye. And if you’ve got good friends, love them while they’re here.”
Ecco, la risposta è no, non capitano casualmente. È stato un periodo di addii negati, di persone perse senza uno sguardo reciproco. Un ultimo, consapevole, gesto d’amore. Abbiamo delegato tutto questo senza poterci opporre. È un peso che cala lento.
E allora prendiamoci questo concerto per curarci un po’, per raccontare le nuove cicatrici.
Siamo stati immobili, come pietre, ma la musica ci ha continuato ad illuminare.
Mi giro, I tre sono persi a discutere se con la partenza di Abruzzese sia davvero andato tutto a fanculo.
Sorrido, godiamoci questo viaggio, che mai come in questo 2020 si sta come al Pinkpop sul palco Eddie Vedder.
Your light’s reflected now, reflected from afar
We were but stones, your light made us stars
Dissolvenza in nero
Light Years.
Scena 3
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, pit, esterno, tramonto.
Release
Trovato posto, il nostro posto nel pit, conosciuto i vicini di spalla.
Birre, cesso chimico, birre.
È incredibile come l’alimentazione prima di un evento impegnativo come un concerto sia, generalmente, liquida. Siamo astronauti.
L’aria cambia, sale un po’ di vento ad asciugarci, la sera sta arrivando, porta musica. Pixies andati, visti a Torino e recensiti, sapevo avrebbero fatto muovere le chiappette anche a questi giovini, linee di basso come schiaffi, irresistibili.
Adesso però ho bisogno di un’assoluzione.
Adesso ho bisogno di un’onda sonora che riallinei me al mondo, me alla musica, me a questo momento che aspetto ogni anno, come una medicina unica e rara.
In Let’s Play Two c’è un momento che mi rovina la vista, annacquandola, ogni volta. È all’inizio di Release, quando Eddie introduce la canzone. Cerca un certo John, “wherÈs John?”:
TherÈs a guy named John in the front. WherÈs John?
I just want to point out one guy at the front,
because he was the first guy in line two days ago; four days ago.
And he wanted to be in front for this song, because it meant a lot to him.
HÈs going through some stuff, and wÈre gonna help him.
Sing with me
Musica.
Lo stadio intona insieme a Eddie un lungo e profondo Oooohhhhhhhhh….
How are you doing now, John?
Oh, yeah.
Come va adesso Andrea?
Ho resistito, ho tenuto botta, ho teso i muscoli per mesi, per arrivare qua. Altro che quattro giorni, io è una vita che sto in fila. E sono e sarò John per sempre e per sempre avrò bisogno di essere lì, quando ci sarà bisogno di una “o” bella lunga e bassa, per ritrovarsi, riallinearsi e dirsi, senza troppi problemi che siamo passati attraverso qualche casino e che abbiamo un bisogno fisico di catarsi, di una benedetta catarsi di massa possibile solo attraverso la somministrazione consapevole e volontaria di basso chitarra batteria voce. Ukulele q.b. .
Cari John, lo so che siete là fuori anche voi. È tornato il momento di cantare tutti insieme, anche a cazzo di cane, ma farlo, oggi, qui, è la cosa più bella che ci sia.
I’ll ride the wave where it takes me
I’ll hold the pain, release me
Dissolvenza in nero.
Release
Scena 4
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, pit, esterno, notte.
Rearviewmirror
Dissolvenza in nero
Fin qui tutto bene.
Belle le canzoni di Gigaton. Sognavo di cantare a squarciagola ravanèi remulass, barbabietole e spinass nel nanananaanaanananana di Superblood Wolfmoon da mesi. Fatto.
Mai stato un musone da setlist scadente o presunte tali. Sapevo che anche questa volta non avrebbero deluso. C’è però una canzone che non possono non suonare. Una sola chiedo, perché è importante che mi arrivi addosso cantata da migliaia di persone e da loro, lassù, sul palco.
Fin qui tutto bene.
Poi arriva, chitarra, chitarre, batteria e basso. E via, l’autodromo esplode. Si tira fino al What I could not forgive, Mike ha già le mani al cielo. Adesso ognuno se ne va per la sua strada, poi tornano, poi via di nuovo, io vacillo.
Dissolvenza in nero
Migliaia di mani battono insieme, richiamano e reclamano. Un basso esaudisce i desideri.
Saw Things, per quattro.
Al quarto Eddie è posseduto, occhi chiusi, io galleggio. Le ombre si sono alzate, Mr. McCready è già piantato come un palo, mento in su, in estasi mistica, a sparare note sulla folla, la canzone sta per entrare nella sua terza vita, perché Rearviewmirror è una e trina, è composta, come la parola che la definisce.
Rear-view-mirror.
Batteria che corre i cento metri, io ho addosso un paio di baccanti, il pubblico dietro di me sembra un’onda impazzita.
Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio.
Quando torno sulla terra, finite le note, è come se mi svegliassero da un sogno. Come se mi venisse tolto qualcosa cui tengo tantissimo. È infantile, me ne vergogno un po’, ne vorrei una al giorno di Rearviewmirror, così, tutti centomila insieme.
Insieme.
I hardly believe
Finally the shades are raised… hey
Dissolvenza in nero
Rearviewmirror
Scena 5
Autodromo Enzo e Dino Ferrari, esterno, notte.
Present Tense
Una Baba O’Riley che ha spostato le stelle per volume e che ha fatto ballare i sismografi chiude il concerto.
I sorrisi che si vedono dopo l’ultima nota, a luci accese, sono unici. Non li puoi trovare da nessun’altra parte. Ci sono sorrisi da sport, sorrisi da paternità, sorrisi di complicità, sorrisi irreverenti. Poi quelli da pit, che, con pochi altri, pongono una condizione precisa di tempo e luogo. Me li guardo per bene, me li tengo stretti.
Ho le orecchie che fischiano, le gambe molli, una sostanza simile al vinavil in gola.
Urge una birra, take a bottle, drink it down, pass it around.
I passi che faccio per uscire sono sempre I più pesanti, perché so che sono quelli più lontani dalla “prossima volta”. Oddio, avrei Zurigo, a breve. Però, mi concedo un sorriso ad angoli verso il basso. E un sospiro.
Dissolvenza in nero
Mi allontano. Mi metto in disparte, voglio osservare tutto questo. Perché con tutto quello che è successo ho cambiato il modo di percepire certi eventi. È come se testimoniare la realtà sia diventata un’urgenza. Ed è come se guardare questo nuovo spettacolo, con nelle orecchie ancora le loro chitarre, mi aiuti a digerire marzo e aprile duemilaventi. Non vedere i miei genitori, gli amici, dover lavorare in continuazione per rimanere a galla, l’uscire con mascherina, autocertificazione, le code, la gente impaurita e arrabbiata, gli amici medici, gli amici ammalati, gli amici intubati. File di camion che escono da una città, i telegiornali visti di nascosto, spiegare a mia figlia perché sta succedendo tutto questo, perché i negozi nel quartiere sono chiusi e perché alcune serrande non si alzeranno più.
Chiuso, dentro.
Per fortuna c’era la musica, c’era una famiglia, c’era una bambina con cui ascoltare skipping prima di addormentarsi. Sono fortunato, lo riconosco qui e ora, del resto makes much more sense to live in the present tense.
È un mettere un piede davanti a un altro, come la corsa, metafora da due soldi.
Grazie piccolo esercito di John, siamo stati bene anche questa volta. Alla prossima.
You’re the only one who can forgive yourself oh yeah…
Makes much more sense to live in the present tense…
Dissolvenza in nero
Present Tense
Epilogo.
Sotto un albero, privo di ossigenazione, esterno, giorno.
Come Back
Questa volta mi sono fermato.
Ho un ultimo pensiero per me, per chi è ancora qua. Io a questo concerto ci sono andato davvero.
È durato tre mesi, forse quattro, è nato in quarantena ed è continuato ogni volta che una canzone dei Pearl Jam mi richiamava a un attimo di riflessione, a un pensiero, a un ricordo.
È il privilegio della reminiscenza, anzi, della ἀνάμνησις (anamnesi). È un qualcosa di bellissimo, un regalo della mente. È conoscenza, è il risveglio della memoria destata dalla sensibilità.
O forse non dovevo correre con 32° e assenza di ombra.
Ok, se queste saranno i miei ultimi pensieri, i miei ultimi respiri, lascio volentieri il ricordo di uno cui si alzavano ancora i peli delle braccia alla 456esima Rearviewmirror. Oppure cerco di tenere duro, fino al prossimo concerto, magari vero, questa volta.
Ecco. Come back. Il prima possibile, ne abbiamo tutti, per davvero veramente, un grandissimo bisogno.
E piove di nuovo.
If I don’t fall apart
Will my memory stay clear?
Dissolvenza in nero
Titoli di coda
Come back
Andrea Riscossa
Foto di copertina: Francesca Garattoni