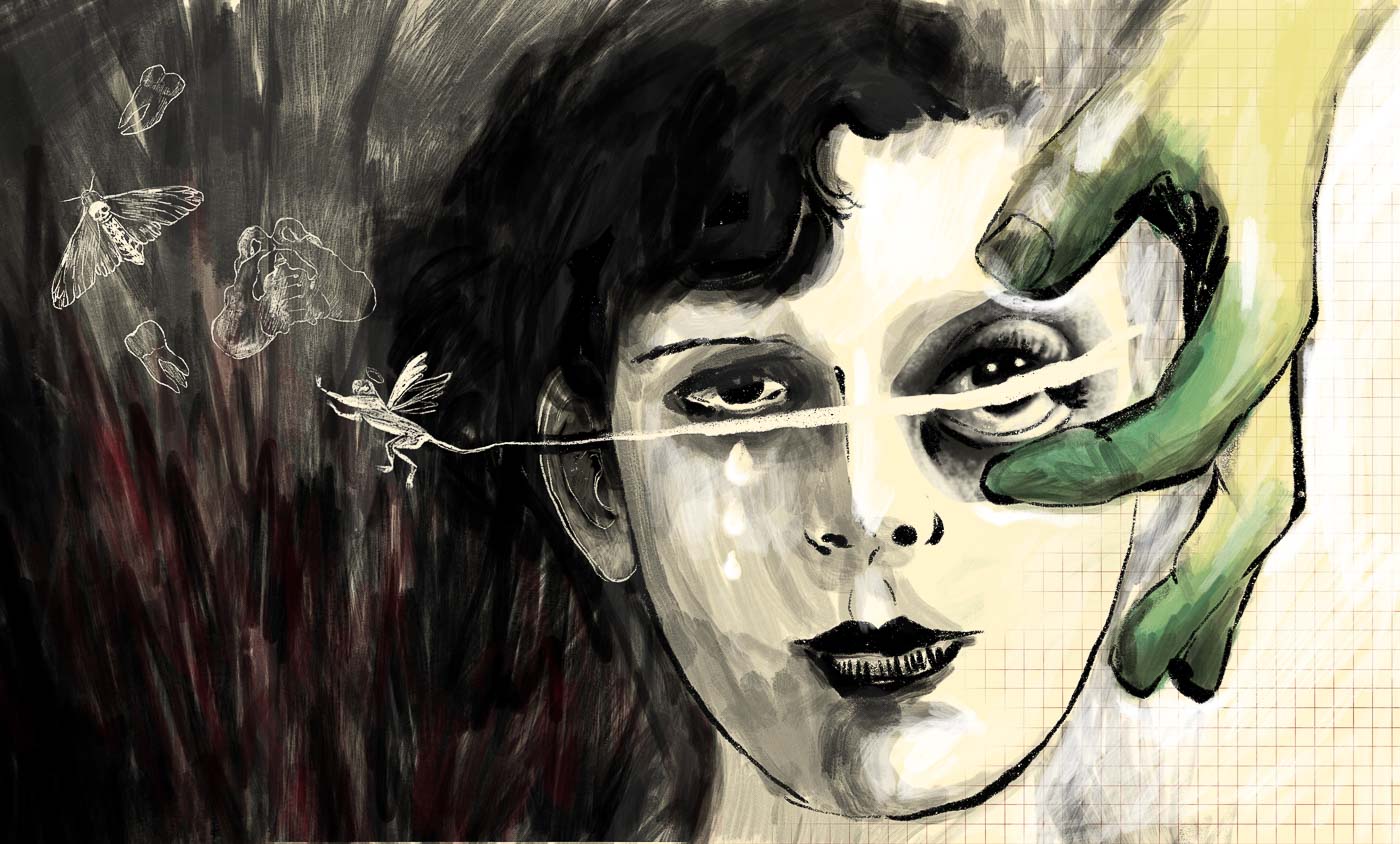Il realismo positivo di Ghemon
È uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano, in grado di unire il cantautorato al rap e al soul. A tre anni dall’uscita di Mezzanotte e con una partecipazione al Festival di Sanremo nel frattempo, Ghemon ha da poco pubblicato il suo ultimo lavoro, Scritto Nelle Stelle.
Abbiamo fatto due chiacchiere al telefono per parlare dell’album, ma anche di concerti drive-in e stand-up comedy.
Ciao! Bentornato sul nostro magazine e grazie per averci concesso quest’intervista.
“Grazie a voi!”
Scritto nelle Stelle ha avuto un’uscita un po’ travagliata: prima il 20 marzo e poi il 24 aprile, sempre in periodo di lockdown. Com’è stato il lancio in questo momento così complicato?
“È stato particolare, sicuramente un lancio che non dimenticherò. Abbiamo preso la decisione di rimandare l’uscita del disco a inizio marzo, quando ancora il lockdown era parziale, ma già si sentivano umori piuttosto oscuri. Alla fine è uscito il 24 aprile, durante la fase discendente e quando si iniziava a percepire un po’ più di fiducia. Sono comunque fiero della scelta che abbiamo fatto, anche se va contro ogni logica commerciale, perché l’accoglienza è stata buona e ho ricevuto molti messaggi in cui le persone mi ringraziavano per averle aiutate con questo disco a trascorrere un po’ meglio la loro quarantena.”
Si è parlato anche dell’ipotesi dei concerti stile drive-in per venire incontro al settore in crisi. Tu cosa ne pensi: meglio aspettare tempi migliori o provare a portare la musica in giro in questo modo?
“Penso che sia meglio aspettare. Non è per una questione di snobismo, ma perché è comunque difficile da organizzare: bisogna tenere conto degli spazi, della logistica e di eventuali assembramenti anche dentro le macchine. Però non credo che questa sia l’unica soluzione. Ad esempio, si è parlato di fare concerti sempre sullo stile drive-in, ma con le biciclette al posto delle macchine. Ad ogni modo, noi continuiamo a guardarci attorno e a cercare più alternative possibili.”
Parlando del nuovo album, fin dalla citazione scritta sulla copertina si capisce che Scritto nelle Stelle è un album diverso, più sereno. Cos’è cambiato dal Ghemon di Mezzanotte?
“Sono io ad essere cambiato [ride]. Alla fine sono passati tre anni dall’uscita di Mezzanotte e per certe cose tre anni significano davvero un’era geologica. Sono cambiate le mie relazioni, il mio stato d’animo, il mio umore e ho fatto esperienze diverse, quindi avevo bisogno di raccontare questo posto nuovo in cui sono arrivato, di raccontare una sorta di nuova primavera, invece che rimanere ancorato alla nostalgia di una stagione passata.”
I tuoi testi sono sempre molto sinceri. C’è uno sforzo dietro o ti viene naturale?
“È una cosa naturale. O meglio, all’inizio c’era sicuramente uno sforzo maggiore dietro, ma con la forza dell’abitudine questa sincerità è diventata la normalità. Volevo abbandonare la divisa da supereroe per cercare di cantare canzoni che dicessero la verità e mi rendo conto che è stata una scelta che ha dato i suoi frutti.”
C’è una canzone di Scritto nelle Stelle a cui ti senti particolarmente legato?
“Non è una domanda facile. Sono molto legato a tutto il disco perché dentro c’è tutta una serie di cose che volevo fare e dire e che non ero sicuro se dire proprio in questo modo o meno. Ci sono soprattutto riflessioni che prima non avevo mai avuto modo di esprimere, come in In Un Certo Qual Modo oppure in Un’Anima, che tra l’altro è la mia prima ballad con solo voce e pianoforte. In generale in quest’album c’è un realismo positivo in cui mi rispecchio molto, quindi, nonostante le novità, non direi che si è trattato un esperimento, anzi mi ci rivedo parecchio. Però non c’è una canzone a cui sono più legato di altre, voglio bene a tutte allo stesso modo.”
Sui vari social, soprattutto su Twitter ma anche nei video promozionali su Instagram, sembra che tu abbia sempre la battuta pronta. Qual è il tuo rapporto con l’ironia?
“Credo faccia parte del mio DNA familiare, da parte di mio nonno e di mio padre. Mi piace quel tipo di ironia fatto di battute ghiacciate ma dette con la faccia da poker, come se non stessi davvero scherzando, ed è una bella sensazione quando gli altri ridono per una battuta che ho fatto. Sono un fan della stand-up comedy e qualche volta ho anche provato ad esibirmi. Nelle canzoni tendo a non essere ironico, quindi questo è un modo per esprimere un qualcosa, un altro lato che di solito non traspare quando canto.”
Francesca Di Salvatore