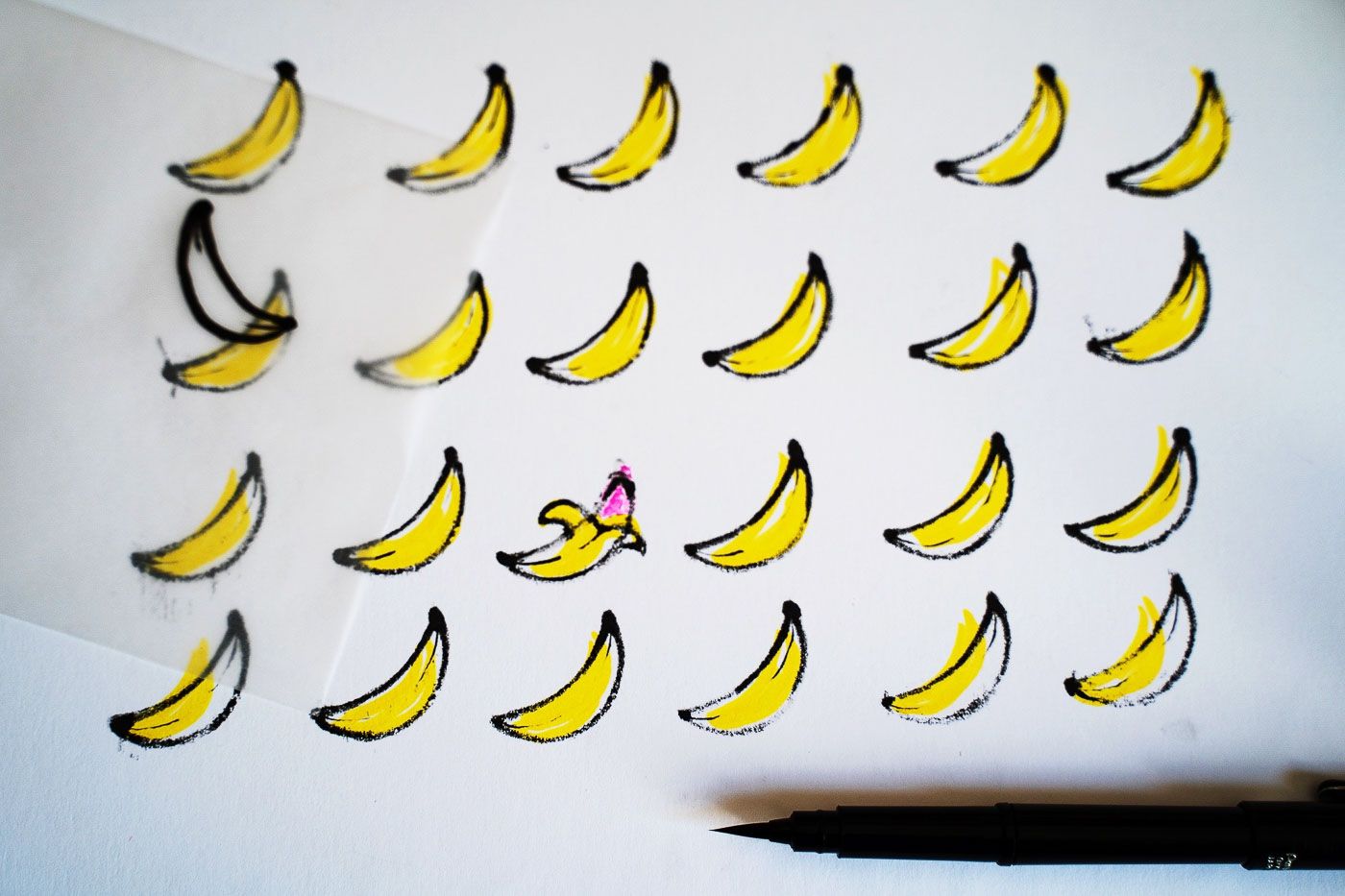Claver Gold & Murubutu “Infernvm” (Glory Hole Records, 2020)
Ho recuperato un articolo che avevo letto da qualche parte anni fa di Umberto Galimberti, nel quale viene raccontato di quando il linguista Tullio De Mauro aveva svolto nel 1976 una ricerca per vedere quante parole, conoscesse al tempo un ginnasiale: 1600 circa. Ripeté il sondaggio vent’anni dopo e il risultato fu tra i 600 e i 700. Prosegue Galimberti dicendo che a parer suo al giorno d’oggi il numero potrebbe essere circa 300, se non meno.
Sull’origine e sulla veridicità di questo studio vi sono pareri contrastanti, per cui non mi va di farne una sorta di assioma, ma di gran lunga più interessante è come prosegue Galimberti nell’articolo, ovvero “come ha evidenziato Heidegger, riusciamo a pensare limitatamente alle parole di cui disponiamo, perché non riusciamo ad avere pensieri a cui non corrisponde una parola. Le parole non sono strumenti per esprimere il pensiero, al contrario sono condizioni per poter pensare”.
Ora: il rap, per sua stessa natura, per definizione, non può esistere senza la parola. Magari senza musica, ma senza parole proprio no. E solitamente nei dischi rap di parole ce ne sono molte, i testi tendenzialmente lunghi, i risultati a volte opinabili, a volte no.
Non voglio attirarmi nemici (ok, anche io a volte non resisto dal buttarmi nella caciara), ma oggi è possibile imbattersi in “Giuro l’altra notte è stato bello / Non esci più dal mio cervello / Non basterebbe un solo anello / Tu vali più di ogni gioiello”, il cui autore non renderò noto, oppure in “E lui che avrebbe superato ed aspettato / Per millenni per poterla rivedere pure solo un giorno / E si sarebbe, da abbracciati, addormentato fra i capelli / Per potersene portare il suo profumo in sogno”.
È un discorso un po’ antipatico, lo ammetto, ed anche leggermente estemporaneo; voglio dire, esiste Messi ed esiste Candreva, ed entrambi appartengono alla stessa categoria lavorativa, ma un paragone così forte e smaccato mi aiuta nel trasmettere quanto sia maestosa e mirabile l’opera (che di questo si tratta) messa in scena da Claver Gold e Murubutu. Scrivo con la pressione di trovarmi di fronte a qualcosa di così vasto da essere incapace di abbracciarlo tutto, di non riuscire a darne giusto merito e rilievo, ma ormai siamo qui e da qualche parte bisogna pur cominciare. Dunque Daycol Orsini, Claver, e Alessio Mariani, Muru, dopo essersi già incontrati in maniera più o meno episodica in passato, hanno deciso di unire le forze per cimentarsi in una rilettura della prima cantica dell’immortale lascito di Dante Alighieri, la Commedia.
Infernvm, così s’intitola, si sviluppa lungo undici tracce, dalla minacciosa Selva Oscura (con un ispiratissimo Vincenzo di Bonaventura) al Chiaro Mondo, costituita da soli sample a tema infernale riassemblati da Il Tenente.
È una discesa agli inferi che parte dall’Antinferno (con il contributo di Davide Shorty, che ricorderete in un X-Factor di qualche anno fa) e prosegue grazie all’anziano traghettatore delle anime “Spinge fiero il vecchio legno nell’oscurità”, Caronte. Qui Murubutu, da professore quale è nella realtà, mi costringe a riprendere il dizionario perché le mie reminiscenze liceale naufragano (sic) di fronte a “Ogni devoto qua ha il suo psicopompo / divinità ctonia della verità”.
È poi la volta di Minosse, col suo beat spiccatamente anni ’90 ed un utilizzo squisito dell’italiano che non può lasciare indifferenti. E d’altronde meglio non correre il rischio di risultare irrispettoso nel trattare temi così alti usando un linguaggio non altrettanto elevato.
E quale argomento migliore se non l’amore, qui affidato a Paolo e Francesca, forse, insieme alla successiva Pier l’empireo del disco, per non cambiare campo semantico. Giuliano Palma fornisce il suo apporto nel ritornello, mentre i due battagliano a chi è più ispirato, Paolo piange mentre Francesca racconta “io che mi esprimerò solo piangendo / e tu parlerai di te come Ginevra”.
Pier ci sbatte in faccia la triste e dura realtà dei suicidi ed in Malebranche troviamo Murubutu a velocità siderale nella sua strofa a presentarci i barattieri; e poi Ulisse, con uno splendido arpeggio di chitarra e la narrazione tra Penelope che aspetta il marito che non farà ritorno: “Cantami o musa dell’Eroe di Grecia e le sue gesta / … / Che sfidò il fato fino all’ultima triste tempesta”.
La dolcezza con la quale una figura come Taide viene calata ai giorni nostri per parlare di prostituzione è commovente, difficile non empatizzare e non calarsi nei panni della protagonista, avvertirne la fatica.
I titoli di coda giungono con Lucifero, in un brano dalle tinte quasi dub, spruzzate di reggae qua e là, che mi portano all’uscita di questo disco con un mix di sensazioni contrastanti, difficili da elaborare: più avanzavo nell’ascolto, più mi addentravo nelle viscere dell’inferno, più provavo sincero stupore e ammirazione verso questi due eroi della parola, per la loro mirabile impresa. Al contempo mi maledicevo per aver sprecato troppo tempo al liceo e non aver seguito le lezioni ed essermene sempre bellamente fregato di mitologia, Dante, figure retoriche, per cui ora devo fare il doppio della fatica per mantenere il passo di Claver Gold e Murubutu.
In effetti l’alternativa per non sentirmi inferiore c’era… come faceva quella dell’anello / gioiello?
P.S. Piccolo inciso (non del tutto) privo di polemica: anche in Caronte i suoni vanno da una parte all’altra, se la ascoltate con le cuffie… voi e il vostro 8D…)
Claver Gold & Murubutu
Infernvm
Glory Hole Records
Alberto Adustini