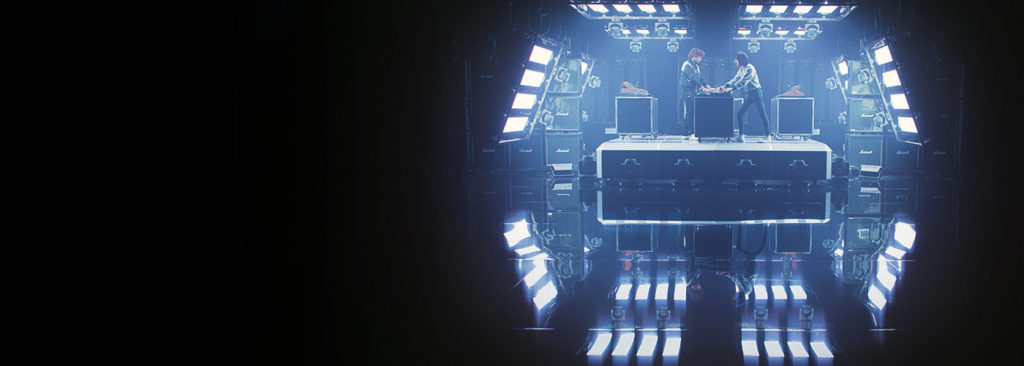Oasis, Knebworth 1996
This is history, right here, right now!
Non capitava, da troppo tempo. Percepire quell’impulso di imprimere, anche soltanto con una parola chiave, una scena, una nota, un’espressione dal potere immaginifico che nasce in un frangente lontano ed unico, ma plasma e modella l’attimo presente. Correre, scorrere su una linea del tempo che tiene insieme una generazione, più di una generazione: quella che ha vissuto di cuore, di pancia agli anni Novanta e quella nata nella stessa decade. Anime benedette e maledette, alcune, per vibrare di un lascito passionale, impetuoso, idealista, fatalista. C’è chi può raccontare, con occhi orgogliosi, l’aver assaporato un’epoca nel suo gusto più autentico e chi può assistere ad un carosello di ricordi a bassa definizione, potentissimi in ogni pixel sgranato, in ogni chitarra distorta.
Non capitava da tempo, da troppo tempo. Perché è la sensazione che ha sempre contraddistinto lo stare in piedi di fronte ad un palco, con la transenna conficcata tra sterno e stomaco, quasi a sorreggere l’apparato dell’emotività. In questo caso, un concerto c’è ma su pellicola, sotto forma di documentario, di gioiello d’archivio. Musica e cinema, due dimensioni al limite del fantascientifico — oggi — in un 2021 post apocalittico in cui il sovvertimento pandemico e planetario ha tracciato un confine netto tra ciò che era prima e ciò che sarà. Ma nessun anacronismo, nessuna nostalgia ingiallita, soltanto verità leggendaria e testimonianze da pelle d’oca in Oasis, Knebworth 1996, il film documentario diretto da Jake Scott sui due concerti biblici della band inglese, nell’area verde dell’Hertfordshire, raggiunta — il 10 e l’11 agosto di venticinque anni fa — da 250.000 persone.
Location battezzata da nomi sacri – Led Zeppelin, gli ultimi Queen di Freddie Mercury – e da subito riconosciuta per quel qualcosa di “aristocratico”. La sfumatura complementare di un gruppo nato tra i quartieri popolari di Manchester, tra le mura intrise di birra e frustrazione dei pub, e giunto a distanza di ventiquattro mesi dall’esordio all’apice della propria carriera e del rock planetario. Un record firmato fratelli Gallagher, capaci di radunare una folla oceanica tanto eterogenea quanto accomunata da un’unica missione: vedere gli Oasis. Ed è proprio sulla prospettiva dei fan che viene incentrata la narrazione, non soltanto dell’evento ma anche di tutto quel corollario di esperienze, di avventure che lo precedono e lo seguono. Capitoli di uno dei tomi dell’enciclopedia della vita, quello relativo alla giovinezza, alla leggerezza, alla speranza. Quello che sporge sempre qualche centimetro in più sullo scaffale. La copertina consunta, il tratto inossidabile delle impronte che, pagina dopo pagina, hanno fatto la storia. Una storia pronta ad essere riletta, riguardata, riascoltata.
“The best of all things that come our way” — La corsa ai biglietti e l’attesa
Nessuna news virale, nessun annuncio ufficiale su siti o social, nessun tweet lanciato alla velocità della luce. Nel 1996, la due-giorni di Knebworth venne accennata da Noel Gallagher durante un’intervista promozionale e, da lì, rimbalzò su cartelloni, riviste musicali, tg nazionali. Il giorno della messa in vendita dei biglietti è riportato alla mente da coloro che parteciparono come un tripudio di sveglie programmate, attese interminabili al telefono, file chilometriche fuori dalle sedi dei circuiti ufficiali, voli dall’Italia con il sogno di due ticket fortunati. Stringerli in mano, vederli arrivare per posta, riceverli in regalo da qualcuno di speciale significava cerchiare in rosso quella data sul calendario. Avere qualcosa di incredibile da attendere. Da organizzare. Non importava quale fosse il modo per raggiungere la distesa più desiderata del Regno Unito (il 5% dell’intera popolazione nazionale tentò in quell’occasione di acquistare i biglietti): a bordo di un’auto sgangherata, di un bus carico di sorrisi e droga o zaino in spalla in direzione di una stazione dei treni dimenticata. Una volta arrivati lì e sicuri che il pass per il paradiso non venisse strappato malamente dagli addetti, tutto ciò che rimaneva fare era correre, correre, correre verso il pit, verso uno scenario in cui tutto era ancora possibile, faccia a faccia con il volto più florido della Cool Britannia e le pose di Liam Gallagher (e magari, prima dello scoccare dell’ora X, assistere all’apertura di band del calibro di Chemical Brothers, Ocean Colour Scene, Manic Street Preachers, Charlatans, Kula Shaker, Cast e Prodigy non troppo valorizzate dalle riprese).
“Maybe you’re the same as me” — Le voci
Oasis, Knebworth 1996 è un’opera di elettricità orchestrale di voci. I video dei live sono accompagnati, o meglio guidati, dal parlato fuori campo dei protagonisti del pubblico che rivivono la storia della musica – “This is history, right here, right now”, per dirla alla Noel – attraverso la loro storia e attraverso le canzoni del cuore della loro band del cuore, quella per cui alla domanda “che cosa regalereste ai vostri idoli?”, qualcuno rispondeva “regalerei anche me stesso”. Dichiarazioni come “Sono fiera di essere loro fan”, “Gli Oasis parlano per noi. Loro sono lì sopra, noi qua ma sono come noi” attivano un effetto di transfert che supera l’ammirazione artistica. Succede quando tra i versi, gli accordi, le pause, le riprese di alcuni brani che hanno rappresentato la colonna sonora di un periodo si intersecano passaggi, tappe e riflessi di chi canta e di chi ascolta. Alla base, un unico comune denominatore: la sincerità. Così con Supersonic ci si elevava allo stato di rockstar, Cigarettes and Alcohol era la fotografia di anni di disoccupazione e tormenti affogati nelle nell’amicizia e nell’eccesso, The Masterplan divenne il manifesto a cogliere le occasioni che l’esistenza riserva come doni, come attimi irripetibili da trascorrere con qualcuno prima che, per la crudeltà del destino, se ne vada per sempre. “È stata l’ultima giornata che trascorsi per intero con mio fratello. Dopo pochi mesi se in andò a causa di un tumore”, confessa una delle fan coinvolte nel progetto. “Alcune ore prima del concerto, scoprii che la mia ragazza era incinta. Sarebbe cambiato tutto. Con la pioggia che scese durante I Am the Warlus venne lavata via anche la mia giovinezza. Non lo dimenticherò mai”, è l’istantanea di un altro speaker, dietro le quinte.
E poi le voci che animarono il palco. Liam Gallagher che poteva permettersi qualsiasi cosa, avvicinandosi al microfono, digrignando i denti, allungando foneticamente i vocaboli, incrociando le mani dietro la schiena. Lo stato di grazia del miglior frontman del momento. Un timbro nitido, acido e possente che rispecchiava una classe, la working class settentrionale, e un genere, l’indie, che, con loro, diventò a tutti gli effetti mainstream. “Tutto cambiò dopo Live Forever”, ammette Noel Gallagher, autore del singolo spartiacque. Lui, cinque corde, voce e soprattutto penna della band, capace di miracoli – “Scrissi Wonderwall e Don’t Look Back in Anger in una settimana” e che, con quegli stessi capolavori, fece cantare 250.000 anime che si sentivano a casa in quelle melodie, con la cieca fiducia che la modifica del testo fosse il sigillo di un patto rischioso ma autentico: “But please don’t put your life in the hands of a rock and roll band / Who’ll never throw it all away”.
Provando a sorvolare sul peso specifico pressoché inesistente riservato nel film al bassista Paul Guigsy McGuigan e al batterista Alan White, oltre alle suddette voci, risuonano anche echi di personaggi altisonanti, presenti ed assenti. Richard Ashcroft, “l’uomo senza ombra”, a cui venne dedicata una Cast No Shadow da brividi (ed un “Ripigliati cazzo!”). Il chitarrista Bonehead che sottolinea quanto lo avesse stupito assistere ad un sussulto tangibile di Liam su “Now that you’re mine” di Slide Away (scena che mi ha incollato alla poltrona del cinema). John Squire, chitarrista degli Stones Roses, che salì sul palco per Champagne Supernova, quei 7 minuti della tracklist che tutti aspettavano. Un iconico passaggio di testimone – “Il testimone ce lo eravamo già preso nel ’94″, puntualizza Noel – ed una scia colorata di azzurro che nacque dagli occhi del cantante per accarezzare le lacrime del pubblico. Quei 7 minuti, quell’intro-mantra che, un paio di sere fa, durante la proiezione, tutta la sala attendeva. Atterrita, impaziente ed emozionata.
“You’re gonna be the one that saves me and after all” — Wonderwall
Trai i racconti che si intersecano nel documentario, uno si distingue per lo spazio in cui vennero vissuti i concerti. È quello di un fan che, il 10 e 11 agosto 1996, chiese ai genitori di non essere disturbato, in quella determinata fascia oraria. Nella sua camera, delle audiocassette vergini, pronte per registrare il live dalla radio che lo trasmise in esclusiva. I tre secondi del “cambio lato”, misurati con il cronometro. “Ho portato con me quei nastri per anni, conoscevo a memoria ogni battuta di Liam”. La sua figura malinconica, ma comunque appagata, appoggiata alla colonna vintage di uno stereo ha racchiuso una delle immagini da Wonderwall, da muro delle meraviglie, al cui contatto tutto sembra possibile. Una superficie di sicurezza che svetta fino al cielo. Può essere la spalla di un amico che canta a squarciagola lì vicino, il compagno di avventure incontrato qualche ora prima dell’apertura dei tornelli, la donna che si abbraccia come se quel brano fosse stato scritto per lei. Oasis, Knebworth 1996 si chiude, inevitabilmente, con Wonderwall, una canzone destinata a diventare un inno al di là delle generazioni. Un inno al potere salvifico della condivisione, della musica e dell’amore. E dell’amore per la musica, quello che supera le differenze, le distanze, le difficoltà. Quello che unisce “after all”, nonostante tutto. Quella matrice di cui oggi, soprattutto nel nostro paese, si sente così tanto la mancanza. Quel motore che non ha bisogno di alcun filtro (neppure di quelli degli smartphone, per fortuna assenti all’epoca). Non necessita di alcun compromesso per rendere realizzabile l’impensabile, per sgranare gli occhi di fronte a Liam Gallagher che scende dal palco e regala il tamburello proprio a te, perché te lo aveva promesso. È ciò che fa le storie. È ciò che fa la storia.
Laura Faccenda