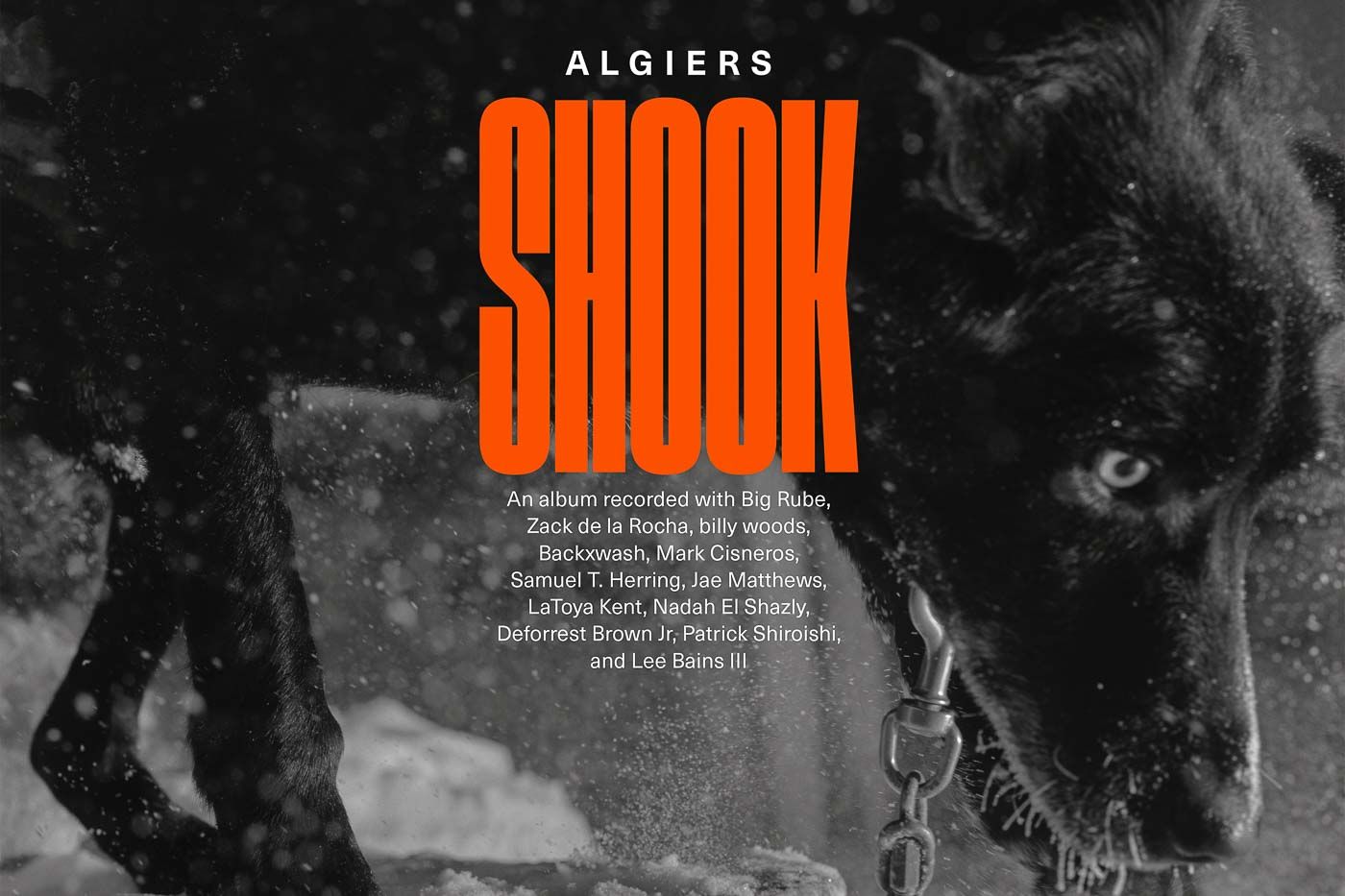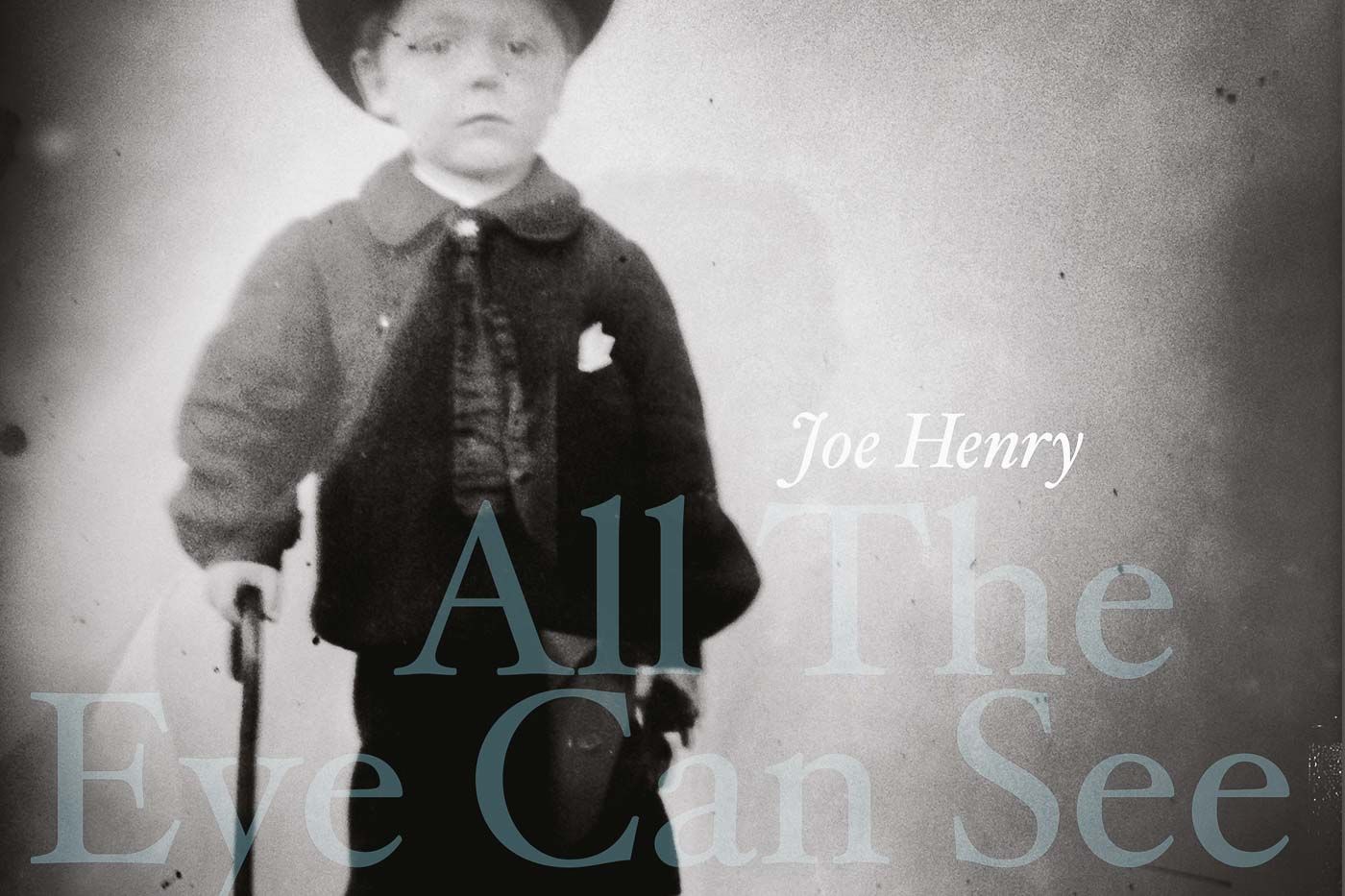First Two Pages Of Frankenstein
Avviso per i più sensibili: anche questo disco ti spaccherà il cuore, cosa quasi scontata per i fan de The National ma, se ti stai approcciando per la prima volta a questa band alt rock di Cincinnati naturalizzata Brooklyn, mi sembra doveroso avvertirti.
Bene, ora che hai preparato i fazzolettini, possiamo cominciare.
Esce oggi l’attesissimo ultimo disco de The National, colmo come sempre di feat di una certa importanza, per la celeberrima etichetta 4AD.
Attesissimo perché il cantante Matt Berninger ha affermato in un’intervista che la band stava avendo diversi problemi: “una fase molto buia in cui non riuscivo a trovare testi o melodie e quel periodo è durato più di un anno. Anche se siamo sempre stati ansiosi e abbiamo litigato spesso durante la lavorazione di un disco, questa è stata la prima volta in cui ci è sembrato che le cose fossero davvero arrivate alla fine”.
Ma, fortunatamente, The National sono stati sempre dei maestri nel saper estrapolare la bellezza anche nella sofferenza e nel dolore, e quindi “siamo riusciti a tornare insieme e ad affrontare tutto da un’angolazione diversa, e grazie a questo siamo arrivati a quella che sembra una nuova era per la band”, afferma il chitarrista/pianista Bryce Dessner.
Il disco inizia con una ballata al pianoforte semplice e romantica, Once Upon a Poolside, che parla della paura di perdersi, emozioni amplificate anche dalla presenza di Sufjan Stevens. Altra canzone da dedicare al proprio partner è sicuramente New Order T-Shirt, singolo che anticipava il disco, con un testo ricco di nostalgia e piccoli dettagli che solo chi è veramente innamorato nota dell’altro. Inoltre, questo singolo, ha portato anche ad una collaborazione con i suddetti New Order per vendere magliette limited edition omaggianti la band di Manchester e donare il ricavato in beneficenza.
Il vero scossone, però, l’ho avuto all’ascolto di Your Mind is Not Your Friend, composta assieme alla cantautrice e chitarrista Phoebe Bridgers, dove attraverso dolci note di piano si parla della paura di affrontare i lati più oscuri della propria mente a causa delle malattie mentali. Altra firma inconfondibile stile National l’abbiamo nel brano The Alcott, caratterizzato da melodie di archi e piano molto scarne e testi introspettivi e quasi brutalmente struggenti. Scritto in collaborazione con la regina dell’Indie Folk Taylor Swift, lei e Berninger interpretano il ruolo di una coppia che cerca in tutti i modi di far rinascere il proprio rapporto ormai finito, ma che nell’ultima strofa sembra aver trovato una nuova luce: “I tell you that I think I’m falling back in love with you”. Dopo esserci disidratati a suon di lacrime, fortunatamente il disco si conclude con un brano positivo e colmo di speranze. Send for Me è caratterizzata da una melodia più strutturata e ritmata, e dalla certezza che c’è sempre qualcuno pronto per te a raggiungerti nel momento del bisogno.
Strazianti ma necessari, The National sono come quel pianto liberatorio che fai a fine di una dura giornata, quello che ti aiuta a superare le ansie e ti dona la carica necessaria per affrontare qualsiasi avversità. Questo nono disco, conferma le enormi capacità introspettive e catartiche della band attraverso melodie semplici che permettono al testo di farla da padrone. Insomma, i Nick Cave americani. E nonostante le due decadi di carriera, la loro capacità di emozionare rimane invariata, anzi ancora più profonda ed viscerale, senza mai diventare ripetitiva.
Alessandra D’aloise