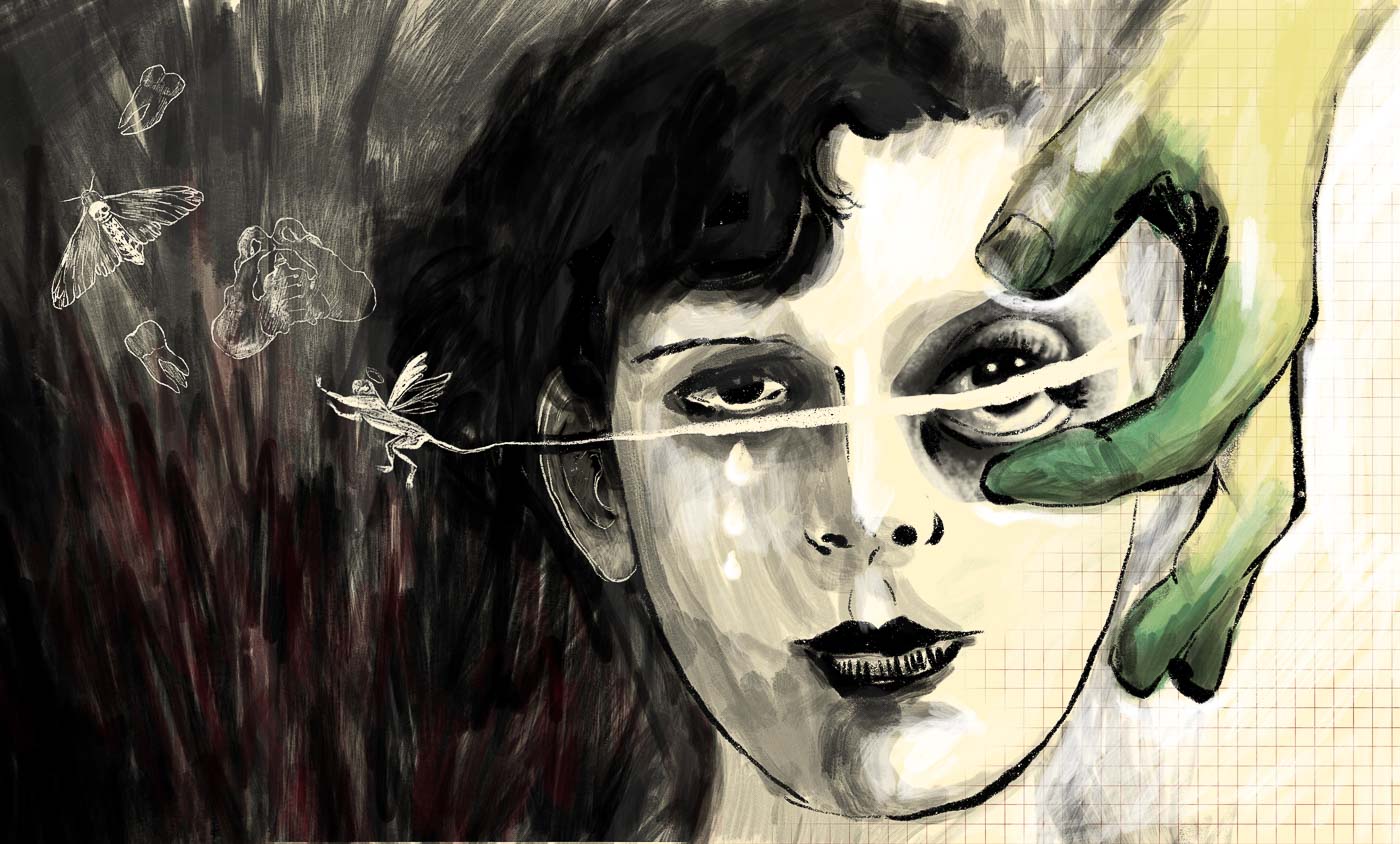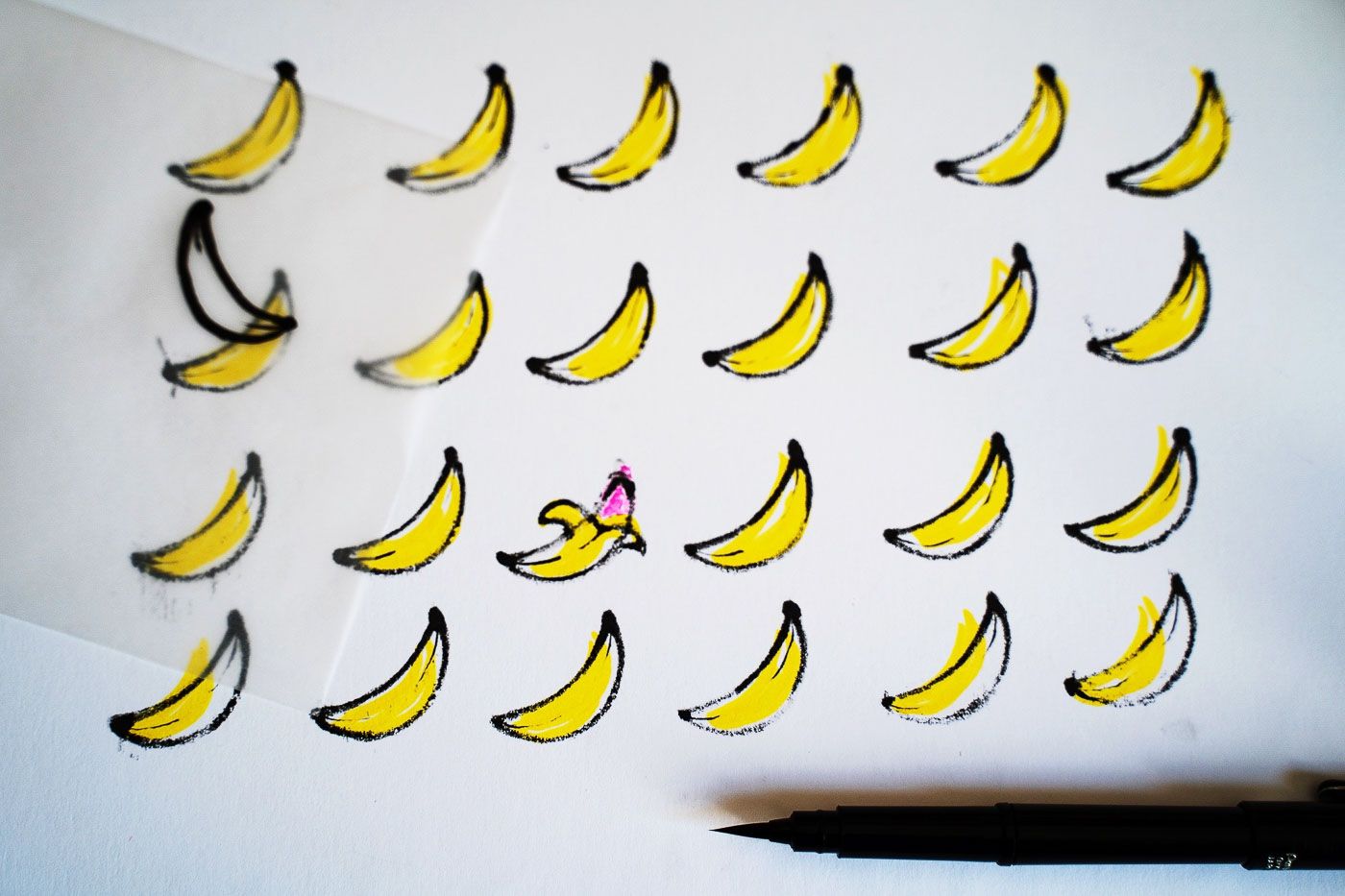Le Ore, duo romano pop composto da Francesco Facchinetti (solo un caso di omonimia) e Matteo Leva, dopo essersi fatti conoscere sul web con alcune cover, hanno raggiunto milioni di ascolti con singoli come La Mia Felpa È Come Me, brano che li ha fatti arrivare nella rosa dei finalisti di Sanremo Giovani 2018. Si sono fatti sentire con Oh Madonna! che è il loro brano con più ascoltatori e salvataggi nelle prime 24 ore. Come tutti i loro brani finora, la traccia è scritta dal duo capitolino, prodotta dal binomio Federico Nardelli/Giordano Colombo (già al lavoro con Gazzelle, Fulminacci e Ligabue) e distribuita Artist First. Il loro piccolo repertorio, ma che punta ad allargarsi, è costellato da un’atmosfera genuina e da una musica che si presenta nuova e rassicurante allo stesso tempo. Le Ore hanno fatto quattro chiacchiere con noi proprio dopo due esperienze importanti come i concerti al Monk di Roma in aperura di Clavdio e all’Apollo di Milano per Spaghetti Unplugged, avvenute lo scorso dicembre, ecco cosa ci hanno raccontato.
Presentatevi ai nostri lettori e spiegateci chi sono Le Ore.
Le Ore: “Piacerebbe spiegarlo anche a noi stessi chi sono Le Ore, ma negli anni c’abbiamo rinunciato, “limitandoci” a fare tutto quello che ci facesse esprimere. Quasi subito abbiamo capito che, raccontandoci in maniera schietta sui social, avrebbe potuto non esserci differenza tra Francesco e Matteo e Le Ore, quindi la nostra avventura partita (pubblicamente) dal web con foto e video, si è poi ricongiunta con la musica che offline facevamo già da tempo, anche se non insieme. Da quel momento cover ed eventi, fino ad arrivare a un punto in cui è stata necessaria una disintossicazione da social network, fondamentale per dedicarci completamente alla scrittura della musica nostra. Siamo tornati quasi un anno dopo col nostro primo singolo La Tenerezza ed è stato uno spettacolo. Solo a quel punto chi ci seguiva ha capito davvero chi fossero Le Ore.”
Le Ore era anche una famosa rivista pornografica italiana che ha fatto diventare famosi personaggi come Cicciolina e Moana Pozzi. Quanto è casuale la scelta del nome e quanto questo immaginario può avere influenzato la vostra musica?
Le Ore: “Sarebbe bello dire che il nostro fosse un tentativo di aprirci una strada nel mondo del porno, ma in realtà quando abbiamo pensato a Le Ore non sapevamo proprio dell’esistenza della rivista. Ovviamente quando abbiamo comunicato il nome ai nostri genitori, i sorrisetti maliziosi si sono sprecati, allora abbiamo capito che dovevamo tenerlo, e che anche gli over 40 se lo sarebbero ricordato facilmente. L’immaginario relativo alla pornografia probabilmente influenza chiunque, anche chi nella vita non scrive canzoni o non ha a che fare con la creatività, a maggior ragione influenzerà chi racconta sensazioni, esperienze e con una pausa, un respiro o con la voce rotta interpreta il verso di un brano.”
Il vostro ultimo pezzo si chiama Oh Madonna!, che può essere considerato sia un’imprecazione che una preghiera, mentre il pezzo prima era dedicato a Radio Maria. Che rapporto avete con la religione, con il sacro e soprattutto con la Madonna?
Matteo: “Sono figlio di un pastore evangelico e da sempre Dio fa parte della mia vita, quando riesco ancora oggi suono la batteria in chiesa la domenica e vivo la religiosità molto serenamente, tanto che quando Francesco mi ha portato il testo di Radio Maria ho appoggiato da subito le provocazioni che c’erano dentro, perché parlano della vita di tutti noi, senza nascondersi dietro a ipocrisie o bigottismi.”
Francesco: “A me non piace bestemmiare nonostante non sia cresciuto in una famiglia particolarmente credente, sono però cresciuto rispettando gli altri che, anche se può sembrare scontato, non lo è, anche nelle migliori famiglie “credenti”. Proprio per questo motivo non avrei mai scritto un brano (o due in questo caso) contro la chiesa, ma non avrei fatto neanche una sviolinata. Radio Maria parla di una notte di merda in cui, tra l’altro, in macchina parte Radio Maria. Non è altro, quindi, che un semplice giudizio sulla stazione radio in sé che parte nei momenti meno opportuni, di conseguenza la frase “se sento un altro prete che canta da domani cambio mestiere”. Oh Madonna! invece è una delle esclamazioni più usate, l’accezione dipende dal contesto, ma in entrambi i casi è soft, quindi no problem: “Oh Madonna! Quanto sono felice quando sei felice. Oh Madonna! Quanto sono triste quando sei felice senza di me…”.”
Il vostro sound e la vostra scrittura potrebbero tranquillamente essere associati al cosiddetto it-pop ma si sentono anche molte influenze del cantautorato dello scorso secolo. Poi siete prodotti dal duo Federico Nardelli/Giordano Colombo, che hanno già lavorato con artisti come Gazzelle, Fulminacci e persino Ligabue. Quanto vi sentite vicini a questa corrente musicale e quali sono le vostre principali influenze?
Matteo: “Se cominciassimo a parlare delle nostre influenze musicali servirebbe una rubrica a parte, quindi ci limiteremo a citare i background che ci rendono diversi ma (forse) complementari. Francesco è la persona musicalmente più acculturata che abbia mai conosciuto, il suo genere preferito fin da piccolo è la musica black, quindi dal blues all’RnB più moderno, ma l’ho conosciuto già ferratissimo su tutta la musica pop internazionale e italiana del secolo scorso, oltre alla musica alternative, quella sperimentale, generi e sottogeneri che faticherei ad elencare. Io invece ho ascoltato veramente tanto rap, italiano e oltreoceano da piccolo, passando per il punk, pop punk, pop rock crescendo, costruendo inevitabilmente un mio bagaglio più “da band”, che unito allo stile più solista e cantautorale di Francesco ha dato vita a un bagaglio unico più ricco. Per quando riguarda la scena it-pop, se fatta con onestà intellettuale e libertà creativa, è una scena che lascia molto spazio alla musica ispirata da correnti e influenze tra le più disparate, perciò ci fa piacere essere accostati ad artisti che stimiamo, poi ci sono anche quelli che ci sembrano un po’ meno onesti e un po’ troppo atteggiati, ma non è questa la sede per parlarne.”
Siete un duo romano e non lo nascondete. Quale è il vostro rapporto con la città eterna e con la sua tradizione musicale?
Francesco: “Io sono di Viterbo, ma mi sento parte di questa scena romana anche perché Le Ore sono nate a Roma e sono diventate quelle che sono, a livello umano e creativo, nelle notti insonni in giro per la capitale, che senza dubbio è la città più bella al mondo. Proprio per l’amore che proviamo per Roma, frequentiamo sempre di più Milano, per lavoro, per le opportunità che offre e soprattutto per la qualità della vita là. Roma la amiamo al punto da non poterla vedere così, al punto da volerla vivere come i nostalgici che tornano e la abbracciano dopo due settimane passate fuori, perché gestita male, pensata male, perché inchiodata e stanca, stancata dagli stessi romani che troppo spesso non si rendono conto delle responsabilità che hanno, per non parlare poi dell’amministrazione.”
Nelle vostre canzoni sentiamo synth, autotune, assoli di chitarra e break elettronici, con un cantato e una scrittura di testi che ruba da vari generi, come fosse un ponte fra diverse epoche e diversi modi di concepire la musica. Vi sentite un progetto senza tempo?
Le Ore: “Una domanda bellissima che ricorderemo per sempre, seriamente. Sarà che ci chiamiamo Le Ore, che si sa possono passare (e oggettivamente passano sempre), ma possono anche restare in testa, su una pellicola o su un hard disk. Nonostante ci sia un’evoluzione nel sound dai nostri primissimi singoli, effettivamente gli elementi digitali non schiacciano mai del tutto quelli analogici e viceversa, così come le frasi più retoriche o d’impatto non sono mai da sole, ma affiancate da discorsi più quotidiani scritti (e pronunciati) come faremmo ogni giorno nel parlato. Più che una domanda, a cui oggettivamente è impossibile per noi rispondere, prenderemo questa questione come un complimento e siamo felici così.”
Proprio recentemente avete iniziato con i live in delle cornici molto speciale per questa scena musicale, cioè il Monk di Roma il 13 Dicembre e l’Apollo di Milano il 15. Come sono andati questi concerti?
Le Ore: “È stato bello e sembra scontato dirlo, ma non lo è, soprattutto per chi ha sempre fatto tutto da sé: da rimediare gli eventi in cui suonare live con le cover a fare le grafiche o i montaggi dei video per i social, quindi poter (per la prima volta) non inserire nemmeno un brano di altri in scaletta è stato per noi una soddisfazione. Roma è casa ed è stato bello vedere facce nuove che ci hanno conosciuti su Spotify e sapevano le canzoni a memoria, idem a Milano, dove siamo stati felici di portare la nostra musica all’Apollo, club in cui negli ultimi mesi abbiamo visto (e conosciuto) alcuni dei nostri artisti preferiti.”
Con il vostro precedente singolo La Mia Felpa È Come Me vi ha fatto arrivare fra i finalisti di Sanremo Giovani 2018. Cosa vi ha lasciato questa esperienza?
Francesco: “Adesso sono passati tre singoli da La Mia Felpa È Come Me, dopo aver fatto Sanremo Giovani sono passati nove mesi prima di tornare con Ci Metti Il Resto e non è stato un caso. Quello che raccontiamo in quel pezzo ha tanto a che fare con l’esperienza sanremese, con il mondo intorno che ti forma, ti sforma, ti arricchisce o ti deruba, ma per rendercene conto dovevamo necessariamente far spegnere un po’ i riflettori (una cosa che periodicamente ritorna nel nostro percorso) e capire chi fossimo noi, più che come persone come artisti. Quando sei a Sanremo l’emozione è tanto grande, soprattutto per chi come me è cresciuto attaccato alla tv sbavando per Pippo Baudo [ride], sentirsi presentare in diretta su Rai1 proprio da lui è una cosa che porterò dentro finché morte non mi separi da questo mondo. La band della Rai, gli amici, i colleghi, mai visti come avversari, ma come compagni di una gita privilegiata e inaspettata che ci ha dato e lasciato tanto. Dico sempre che in quei dieci giorni siamo cresciuti di due anni, ed è vero: la prima volta in tv, la prima volta con gli ear monitor, la prima volta di fronte a tanti addetti ai lavori con cui, tra l’altro, siamo in contatto ancora adesso. Questo è uno di quegli aspetti che, se non sei abbastanza in grado di gestire te stesso, ti si può anche rivoltare contro, perché in tanti sembrano avere la ricetta per il tuo successo in quella situazione, ma, se ci pensi un attimo, il vero successo è continuare a mettere un piede davanti all’altro come hai fatto fino a quel momento. Perciò abbiamo preso tutto il bello di Sanremo e ne siamo fieri, l’esperienza, la musica, chi la ascolta, chi la fa, chi ci aiuta a farla meglio, il resto l’abbiamo lasciato là, perché non ci interessava e non ci interesserà mai, vedi la competizione o le varie logiche per voler apparire più di faccia che di musica.”
Quali sono i vostri progetti futuri? Cosa avete pronto nel cassetto?
Le Ore: “Tanta musica, ne scriviamo di nuova ogni giorno, sperimentiamo coi suoni e con i testi, ci spingiamo laddove riusciamo a sorprendere noi stessi, con il pensiero a quella musica sui palchi di tutt’Italia. Vorremmo solo questo, ma non per il 2020 ma per il 2000 e sempre.”
Per concludere, consigliateci un libro, un disco ed un film per conoscervi meglio.
Le Ore: “Se la domanda numero quattro avrebbe avuto bisogno di una rubrica a parte, questa avrebbe bisogno di un blog tutto suo. Siamo malati di cinema, evidentemente anche di musica e sappiamo apprezzare i buoni libri, anche se per mancanza di tempo spesso si accumulano sul comodino. Saremo brevi e concisi con i primi che ci passano per la mente: libro Il Cardellino di Donna Tartt, disco Modern Vampires of The City dei Vampire Weekend, film Parasite di Bong Joon-ho.”
Gianni Giovannelli