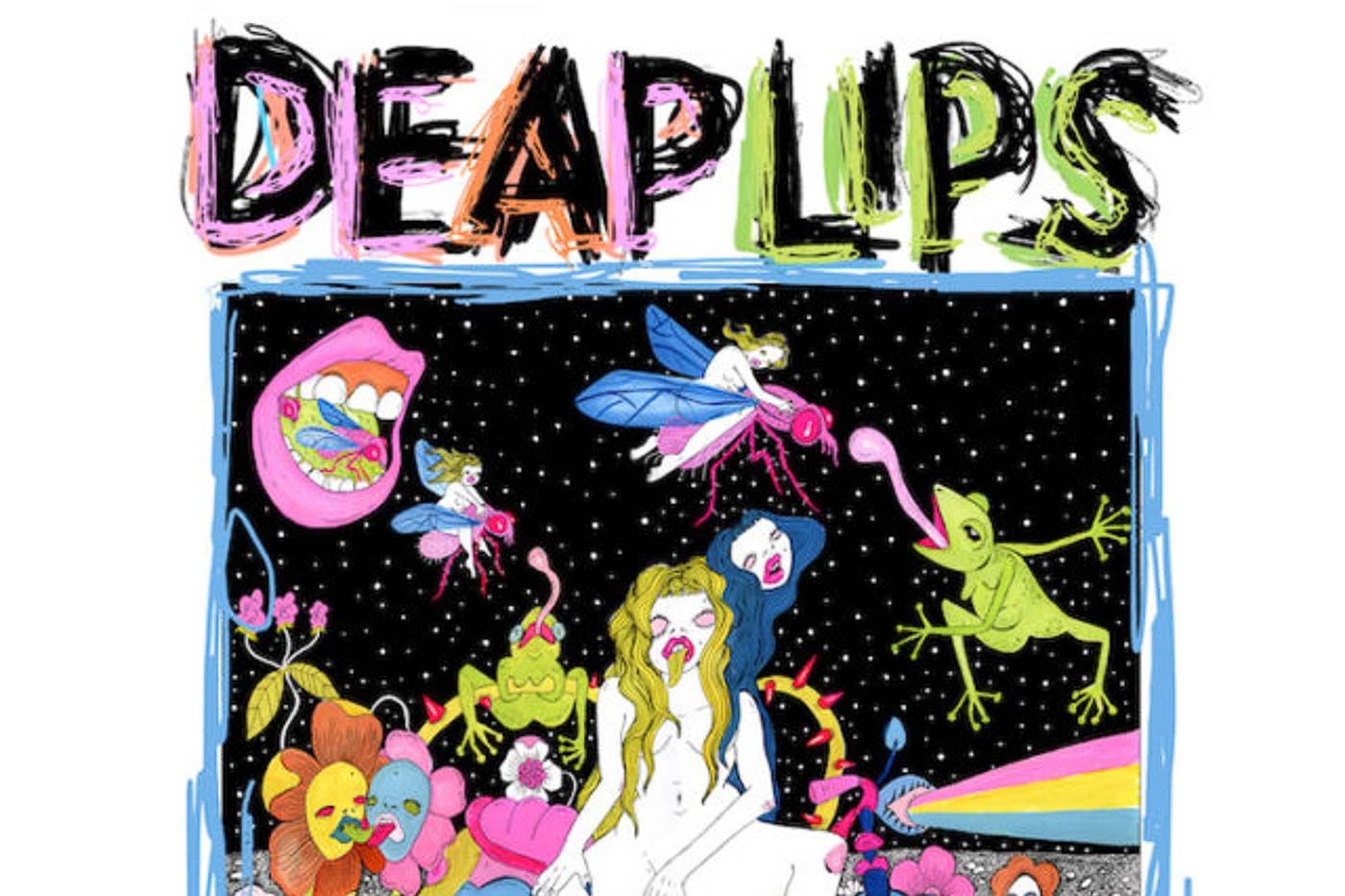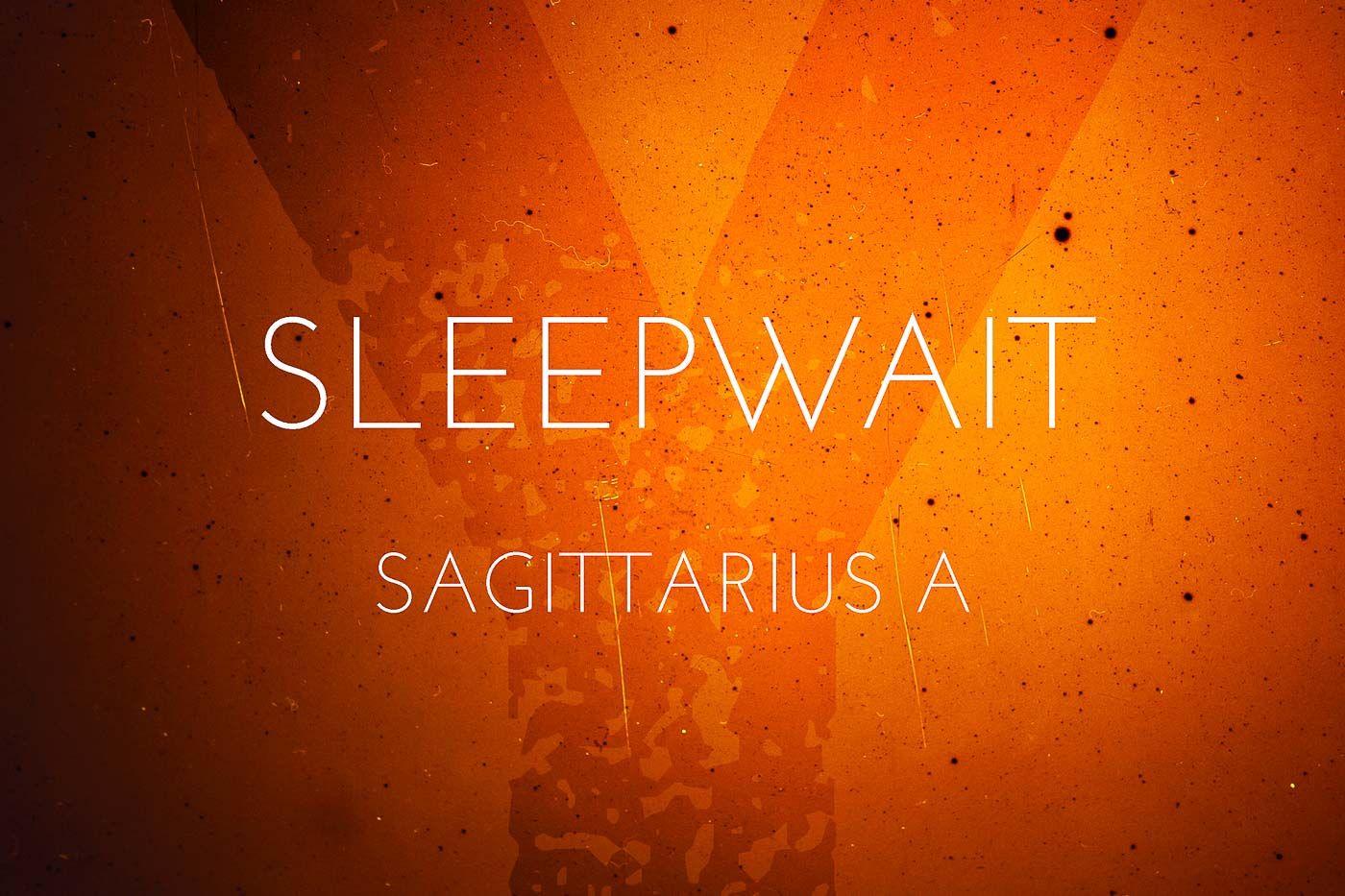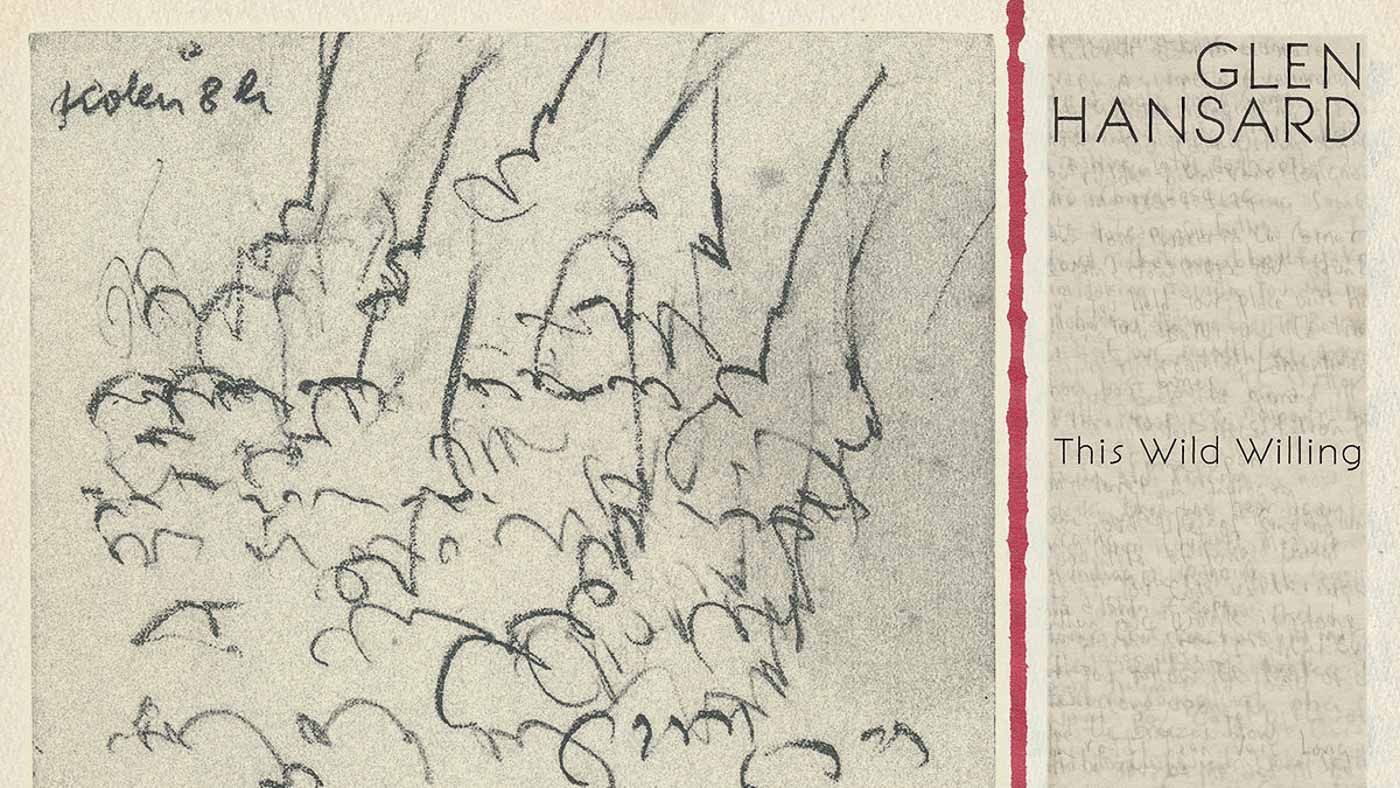Pearl Jam “Gigaton” (Monkeywrench Records, 2020)
So save your predictions
And burn your assumptions
Tier I
Alla fine ho dovuto passare alle maniere forti.
Mi sono regalato la mia naturale miopia, levandomi gli occhiali. Anzi, ho proprio chiuso gli occhi.
Le cuffie a un volume illegale, perché di volumi illegali (e parlo di sonorità dispiegate e di peso dei testi) questo Gigaton ne è pieno. Sarà l’una di notte, ma poco importa, mi sono autodiagnosticato un cabin fever da quarantena e autoinflitto un jet lag da recensione. Non ho mai scritto cinque pagine fitte di appunti per nessuna recensione prima. Il problema è che sono di parte, molto di parte, in questa vicenda e ho un timore profondo ogni volta che un mio dito si abbassa verso la tastiera. Forse per la prima volta avverto un vago senso di responsabilità, innanzitutto verso me stesso, perché sono chiamato a esprimere un giudizio (anche se non vorrei, ma è inevitabile) su un qualcosa che, dopo sette anni di attesa, ha quasi l’aria di essere un oracolo, più che un disco.
E in seconda battuta mi sento responsabile perché, tra isolamento e tempesta emotiva calcolabile in gigatoni, sto tecnicamente sperimentando la menopausa. Sbalzi emotivi di questa portata li ho visti solo in alcune signore quand’ero fanciullo. Da oggi avete tutta la mia più sincera solidarietà. Questo, inevitabilmente, offusca la mia percezione. Anche se, a dirla tutta, credo l’abbia semplicemente accelerata. Perché è dai tempi di Vitalogy che per esprimere un giudizio su un lavoro dei Pearl Jam, di solito, impiego mesi.
La compressione ha aiutato, qualcosa si è smosso con largo anticipo.
La verità è che a smuovere qualcosa ci aveva già pensato Dance of the Clairvoyants, primo singolo uscito il 21 gennaio, che ha portato alla luce un sound inedito e innovativo, un potenziale cambio di rotta da parte dei cinque, o semplicemente un avviso ai naviganti: destatevi, ma soprattutto “mettete in salvo le vostre previsioni e bruciate le vostre supposizioni”.
Un cambio, fisico, è avvenuto: a produrre l’album c’è Josh Evans, colui che negli ultimi anni ha seguito il gruppo come tecnico del suono. Ha creato una sorta di studio casalingo dietro casa, per permettere a Vedder e soci di lavorare in tranquillità e soprattutto rispettando tempi dilatati e assenze frequenti, tra tour solisti e progetti paralleli è stato raro vedere i Pearl Jam riuniti in sala di registrazione a improvvisare. È stato più un lavoro di stratificazione, di innesti, di montaggio artigianale. Nel 2017 si è iniziato a registrare, ma la scomparsa di Chris Cornell ha bloccato la genesi dell’album. Probabilmente, ha anche permesso che avvenisse un piccolo miracolo.
È come una fotografia a lunga esposizione. Un diaframma era stato aperto e poi è stato lasciato aperto. Sulla pellicola, alla fine dell’esposizione, sono rimasti tutti i dettagli di quasi tre anni. C’è una montagna di tempo in questo disco, come se fosse invecchiato (e bene), in attesa di uscire dalla botte.
Che metafore così, al Vedder visto a Barolo, sicuro piacciono.
Il disco apre con Who Ever Said, ed inizia come un concerto live: musica in dissolvenza, pausa, poi entrano loro. Intro, chitarre, batteria, riffone goloso, Eddie.
Qui troviamo la presentazione, il programma dell’opera: un socratico sapere di non sapere, una stoica sospensione del giudizio. Lo dico qui, in partenza: questo è l’album più “filosofico” dei Pearl Jam, in cui la benevolenza di fondo verso i temi trattati è programmatica, è voluta. È lo spirito della scoperta, dell’analisi, che per la prima volta soffoca la rabbia.
Sarà la terza traccia che vi ritroverete a canticchiare al semaforo (o forse più facilmente in cucina, di questi tempi), la prima del nuovo album. Legata alla successiva Superblood Wolfmoon abbiamo un binomio che in un qualunque concerto avrebbe già fatto ballare mezzo stadio. Qui passiamo a un garage rock senza impegno, con tanto di ombrellino e olivina, mentre le parole, come sempre, producono frizione e attrito: qui c’è l’umana condizione, addirittura un platonico mito della caverna, fino alla citazione letterale del “I don’t know anything”. Insomma, tutto pronto per Dance of the Clairvoyants, terza traccia e testo scritto direttamente dalla Sibilla Cumana, solita scrivere i vaticini su foglie di palma lasciate al vento, con conseguente caos eolico-semantico, ma di sicuro effetto scenico. È canzone simbolo di quest’album, perché è sia chiave di lettura sia chiave di volta. Ma è anche canzone doppia, che ha una cicatrice tra prima e seconda parte, platonica, di nuovo, soprattutto nella coda, laddove solo nell’unione tra volontà femminile e maschile si compie la perfezione.
Dopo un volo così iniziatico e criptico ci pensa Mike McCready a riportarci su lidi conosciuti, con un assolo che vale l’intera Quick Escape, prima canzone veramente politica di Gigaton, in cui Trump viene evocato come icona del male incarnato, tangibile. Forse è l’unica traccia un cui il gruppo si permette della rabbia autentica.
Alright è la calma seguente. È onirica ed elettronica, ma anche famigliare, ha echi lontani di sonorità già usate dalla band.
Seven O’Clock è un sogno di un mondo migliore. Una chiamata alle nostre coscienze perché si dèstino, c’è “much to be done”, ci dicono. È per ritmo, tonalità e tema un pezzo springsteeniano, tanto vicino a quella poetica che non mi risulterebbe strano sentire questa canzone eseguita in un fienile, con gli archi e con un tempo ancora più dilatato. Del resto in questi ultimi tre anni Eddie è andato a Broadway ad ammirare zio Bruce e ai nostri non sarà sfuggito il concerto a casa Springsteen.
Never Destination e Take the Long Way sono due umanissime distrazioni, dopo il peso dei primi brani, una meravigliosa doppietta, che fa da eco al primo binomio posto a inizio album.
Buckle Up è la quota Gossard di Gigaton. C’è sempre il suo momento, solo suo, in cui il gruppo lascia la lavagna vuota e il gesso in mano al nostro. Se sei un genitore, questo pezzo ti lascerà sul viso un sorriso da ebete e in testa la consapevolezza che l’amore è un circolo. Almeno in famiglia. È una carezza, indulgente, materna, è un lenzuolo rimboccato e profumo di casa. E’ una canzone sul ricordo, sul valore del ricordo e sulla memoria dell’amore.
Se la pausa del vecchio Stone non vi avesse ancora stupito a sufficienza, ci pensa Vedder nella traccia successiva, Comes Then Goes, in cui la potenza sonora cede il passo a voce e chitarra acustica. Premessa: ringrazio sentitamente i Pearl Jam per non aver ceduto alla tentazione di abusare di steel guitar. Questo brano la chiama a gran voce e so che a casa sua un benharper di periferia ha già rotto una Budweiser per provarci.
Pezzo dedicato a Cornell. Solita frizione tra melodia e testo che risulta essere, strofa dopo strofa, una esplorazione quasi empirica del sentimento del dolore. È una sequenza di immagini che hanno il lutto come tema centrale, ma termina privo di giudizio, è una declinazione, o semplicemente lo esorcizza cantandolo. Che per una band di Seattle, nata negli anni novanta, è un signor passo avanti, fidatevi.
Ma i ragazzi si stanno perdendo. C’era un filo all’inizio, un’intenzione, un messaggio. Lo ritroviamo in Retrograde. Fatte le nostre considerazioni, esplorato il mondo e osservata la situazione è il momento di agire. È un climax, che termina con un’immagine quasi biblica: la folla, destata, ha il rumore del tuono. Gli strumenti in coda diventano un’onda, il pezzo di gonfia, diventa monumentale, quasi orchestrale.
E poi arriva lei.
Mi aveva lasciato stordito a Firenze nel 2019. La aspettavo in Gigaton per tenerla con me e poterla consumare. Ma qui, come capita nei grandi dischi, la grande canzone diventa qualcosa di ancora più grande se arriva dopo undici brani. L’ultima canzone, dopo undici album. E poi saranno ascolti infiniti. E poi sarà attesa per i live.
Questo ultimo pezzo, fatto di organo a pompa, voce, un contrappunto, un Cameron ispirato e assenza di chitarre, sembra ancora di più una preghiera laica. Un’invocazione che chiude le tematiche del disco: il futuro, individuale e collettivo, i cambiamenti climatici, il risveglio delle coscienze, l’essere umano nella sua consapevole imperfezione.
Chiude l’album più lungo della storia della band.
Ascoltarlo durante una pandemia globale, è detonante.
Ha catturato lo spirito del tempo, come se il disco fosse un manuale di istruzioni per momenti bui, che, dicono i chiaroveggenti, sono inevitabili.
E allora “save your predictions and burn your assumptions”. Tabula rasa, spazio all’umanesimo dei Pearl Jam.
Pearl Jam
Gigaton
Monkeywrench Records
Andrea Riscossa