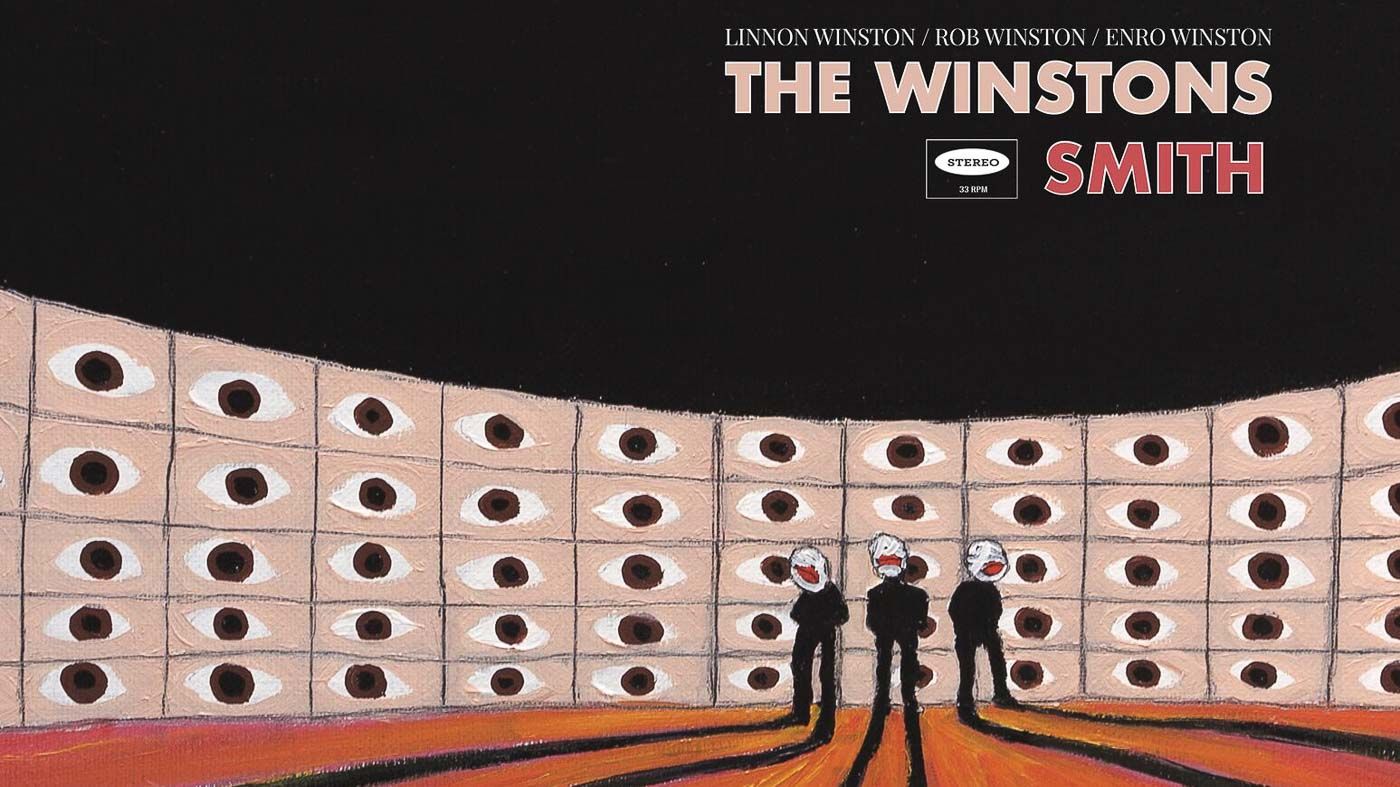Allusinlove “It’s Okay To Talk” (Good Soldier Songs/AWAL, 2019)
Rock is not dead: a rianimare la scena rock mondiale ci pensano gli Allusinlove, quattro ragazzi inglesi, direttamente da Castleford, con assoli micidiali, spiccate doti vocali e batteria martellante.
Una vita da vere rockstars, la loro. Giovani difficili, amanti delle droghe e della vita portata all’eccesso che li ha proiettati in un percorso di introspezione e di crescita personale, il cui risultato è un cambio nel nome della band e un utilizzo diverso della loro musica come mezzo di comunicazione per temi più profondi, con un sound totalmente rock’n’roll.
Gli Allusinlove (già conosciuti come Allusindrugs) debuttano con il loro primo album It’s ok to talkuscito il 7 giugno e non sono più una band adolescenziale, ma un fenomeno rock.
Questo esordio è totalmente autobiografico: è palese il graffiante dolore di chi, in quelle storie narrate nei testi delle loro canzoni, c’è passato realmente ed è riuscito a rinascere dalle proprie ceneri come delle bellissime fenici inglesi.
È un viaggio attraverso le loro esperienze negative, per condividerle con l’ascoltatore, essere d’aiuto a chi si sente solo e dimenticato.
Il primo estratto All Good Peopleè basato sulla positività, sull’amore verso il proprio corpo, sul vivere delle sensazioni che la corporeità altrui ci regala, prendere coscienza della fisicità. Il tutto in pieno stile rock’n’roll, vocalizzi puliti, batteria potente, assoli di chitarra da brividi e un ritornello spaccacranio.
Esteticamente possono sembrare classici bad boys, tatuati e capelloni, tipi tosti insomma, ma con un cuore di panna.
Espongono tutto il loro delicatissimo mondo interiore fatto di amore non ricambiato, dolore, incomprensione, rabbia, solitudine ed alienamento.
Musicalmente ricalcano le vecchie glorie del rock, come nel pezzo Full Circlein cui ritroviamo accenni ai Black Sabbath, un perfetto connubio di chitarre basse, circolari, e assoli magnetici, che tratta di abbandono e incomprensione.
Gli assoli compaiono in quasi tutti i brani, potentissimi e seducenti. Uno dei migliori, in All my love, brano che concretizza la loro voglia di scendere in profondità nei rapporti, e di non arrendersi mai.
Testimoniano la fragilità e la superficialità dei rapporti moderni, in Bad Girls, dove espongono un classico esempio dei problemi nei rapporti moderni, un tipo di amore malato (amami/feriscimi come se ne avessi bisogno), un attaccamento morboso a qualcuno nonostante il dolore che ci provoca. Corriamo per raggiungere il nostro amore, mentre lui si allontana portando via pezzi di noi.
Nell’album è presente anche un loro vecchio brano, uno dei primi, Sunset Yellow, ed è in questo pezzo che risulta palpabile il cambiamento della band a livello sia di testi che di esecuzione, lasciandosi alle spalle gli atteggiamenti fortemente collerici e rancorosi degli esordi.
Attraverso la loro musica curativa, in It’s ok to talk(brano che dà il nome all’album), incoraggiano l’ascoltare più delicato, più problematico, a parlare dei dilemmi della sua anima, senza paura di essere giudicato debole, perché quello che più spaventa è aprire i canali del cuore e sentirci rifiutati.
Questi quattro ragazzi di Leeds sono l’emblema di una gioventù all’insegna dell’esagerazione, rappresentano chiunque di noi abbia passato un’adolescenza sopra le righe, in puro stile rock punk, quando non si ha la consapevolezza che si matura poi col tempo. Quando abusare di ogni sostanza sembra l’unica soluzione, annebbiare la mente per far zittire i demoni che popolano la nostra testa, pur di non comunicare, di non confidarci, di non guardarci dentro.
Gli Allusinlove sono maturati, crescendo hanno capito che l’unica via di salvezza da noi stessi è manifestare la nostra interiorità, esprimere i nostri sentimenti per esorcizzare tutte le nostre paure. L’unica cura è l’amore e la comprensione, perché la rabbia non è costruttiva, ma distrugge tutto ciò che di più buono è stato creato.
Attraverso questo loro primo album mettono al servizio di chi è più sensibile, debole, la loro personalissima esperienza, usando il rock come terapia ai dolori dell’anima.
“The world’s gone mad and it’s getting divided, let’s stand for unity”
Solo restando uniti, facendo squadra e non lasciando i più deboli indietro possiamo andare avanti degnamente.
Allusinlove
It’s Okay To Talk
Good Soldier Songs/AWAL, 2019
Marta Annesi