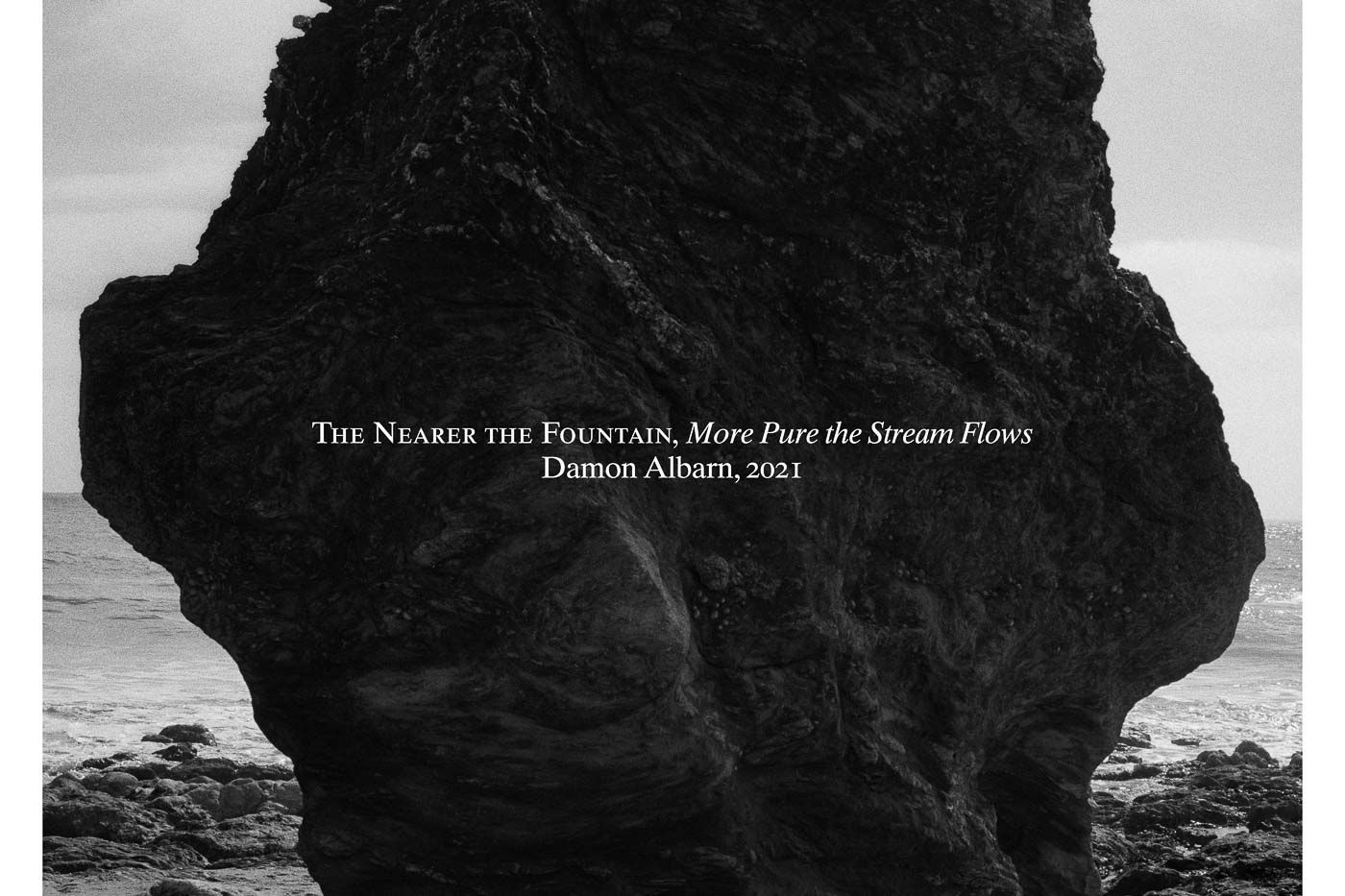Editors “EBM” (PIAS, 2022)
Il confine sottile tra malinconia e piacere
Completamente immobile su una panchina, assisto alla danza malinconica delle gialle foglie. Si tratta di un duetto, il vento le sospinge, le accompagna in questo loro ultimo viaggio che è unico, non esistono due foglie che ballano allo stesso modo.
E la loro fine non è solitaria, anzi, entrano a far parte di un collettivo, un infinito tappeto dalle sfumature cromatiche eccezionali. Ogni tappeto emette un suono, una musica tutta particolare. Ci sono tappeti secchi, che scricchiolano come vecchie porte arruginite; vi sono tappeti morbidi e accoglienti, come l’abbraccio di un’amica cara, oppure ci sono tappeti umidi, di foglie bagnate, scivolosi e precari.
Sto lì, persa in questo infinito danzare di colori che mi circonda. Il sapore agrodolce della nostalgia estiva, di occasioni perse e vacanze terminate rende l’autunno una stagione che tutti percepiscono come transitoria e malinconica.
Il grigio velo del ritorno alla vecchia e stantia routine cala inesorabile, accompagnato dalle prime battenti piogge dà la percezione alle persone che non possa esistere gioia, che tutto sia fermo.
Eppure il mondo si sta preparando.
In attesa dell’inverno tutto si trasforma e mi assale la voglia di fare anche io parte di questo mutamento, un’insolita voglia di alzarmi e ballare.
Questo mio sfrenato bisogno è soddisfatto dalla nuova uscita degli Editors, con EBM.
Il gruppo che fu additato come gli Interpol Inglesi, che dai primi anni 2000 calca la scena new wave, dalle sonorità fortemente influenzate dai Joy Division, sforna un disco autentico, decisamente in linea con il loro stile, ma con sferzate pop e elettroniche. Le tonalità dark dei primi anni vengono riscontrate anche in EBM, la loro vena drammatica è sempre presente, anche se ravvivata da sound innovativi per il loro genere.
La loro natura londinese, fumosa e malinconica, contribuisce alla particolarità del loro stile; una personale rielaborazione di gruppi inglesi (e non solo) come i sopracitati Joy Division (anche se il gruppo nega somiglianze), gli U2, Snow Patrol e Radiohead.
L’ottava meraviglia degli Editors ci viene presentata con l’uscita del signolo Heart Attack, in cui realmente il nostro cuore viene messo a dura prova dall’intro elettronica e con sonorità anni ‘80. La voce di Tom Smith ci conduce in un universo di ossessione, in un amore tossico e morboso.
Il secondo singolo sparato sul mercato è Karma Climb, dal testo disperato che si scontra con il suono ritmato del pezzo.
Con l’ingresso ufficiale di Benjamin John Power (Blanck Mass) si dà il via ad una nuova era per il gruppo, e tutto l’album è incentrato sul creare un rapporto fisico con il pubblico, servendosi di un sound elettronico anni ‘80 che divampa nei nostri cuori portandoci a chiudere gli occhi e a smarrirci nella tristezza dei testi.
L’epicità data dai synth è qualcosa che ci riporta indietro nel tempo come in Kiss, quarto brano dell’album. In Silence i toni si abbassano, e la voce profonda di Tom si trasforma in un’emergenza emotiva, una ballad romantica e memorabile, piena di malinconia. Strawberry Lemonade, Vibe ed Educate sono i pezzi che più rappresentano il concept del disco, ossia la voglia di instaurare un collegamento emozionale e fisico con i fans.
EBM è sconcertante proprio per questo motivo: hanno architettato un album che è in grado di farti ballare grazie al sound molto anni ‘80, ma nel momento in cui ti soffermi sul significato di ogni singola parola puoi assaporare la disperazione e la malinconia tipica degli Editors.
Come l’autunno, sono qualcosa che sembra immutabile, statico, ma in realtà in continua evoluzione. Nostalgici e sognatori, depressi ma con una sfrenata voglia di passionalità.
Editors
EBM
PIAS
Marta Annesi