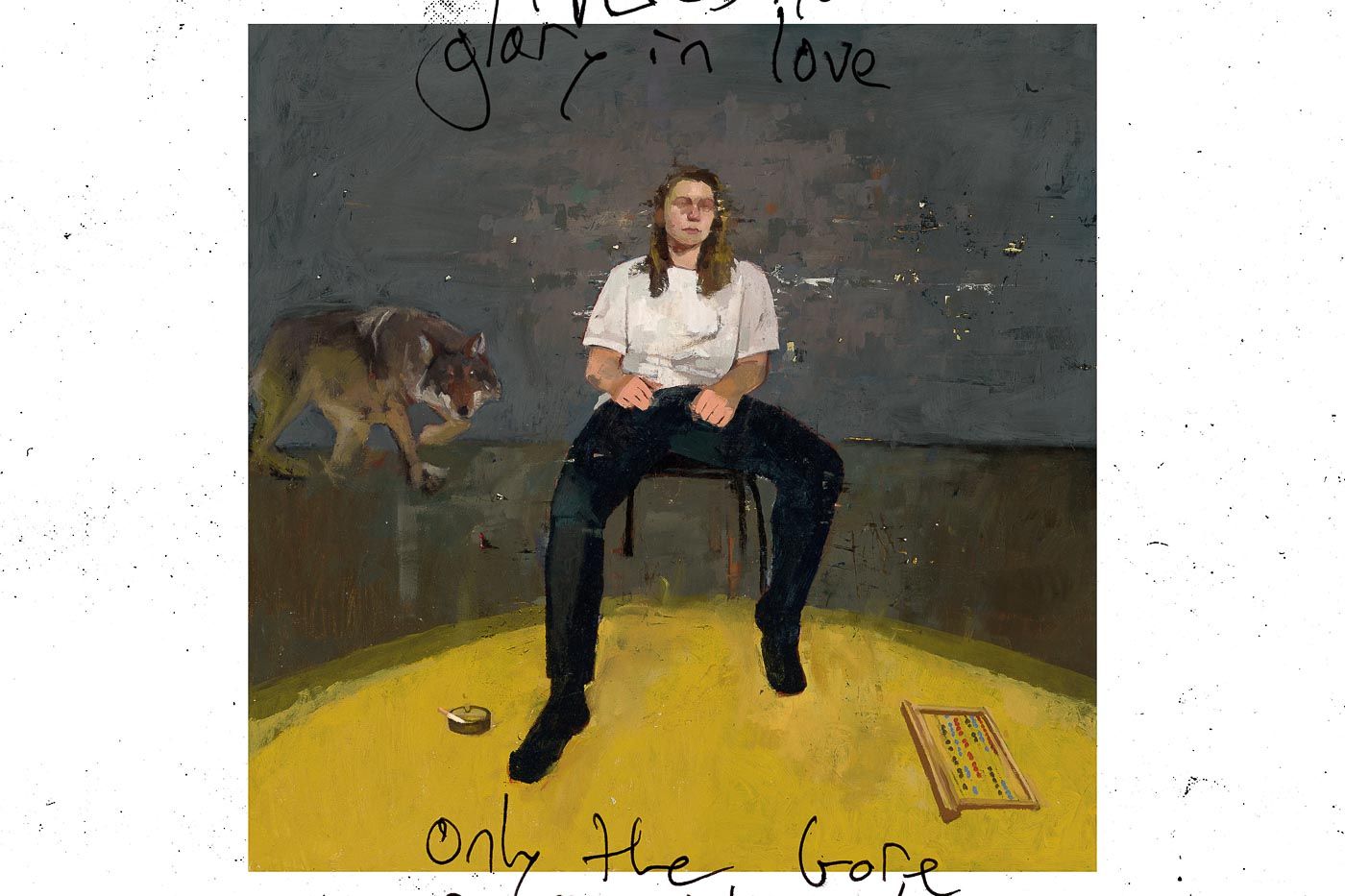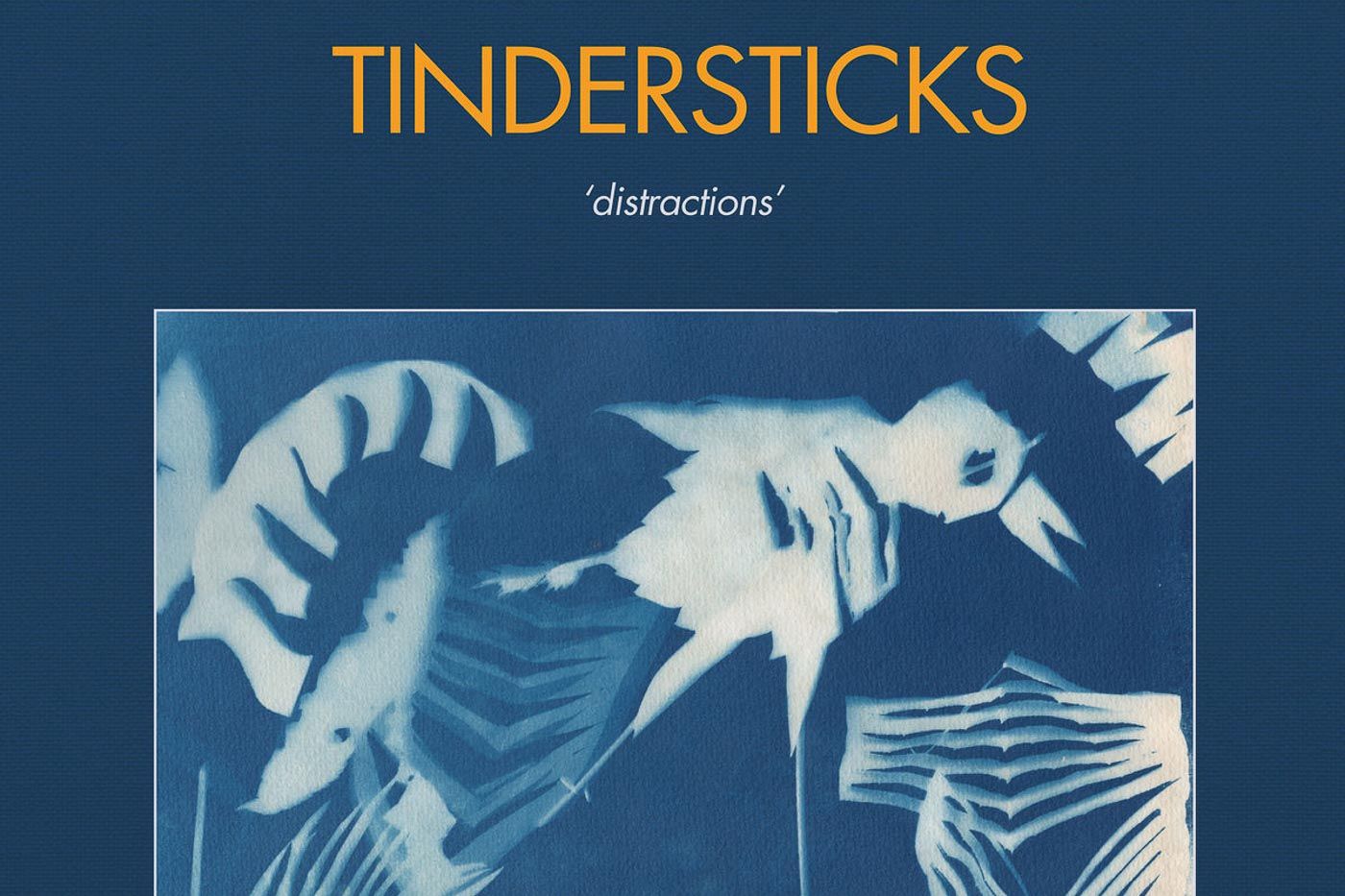Gian Maria Accusani: Riparto da solo (solo per il momento)
Qualcosa si muove? Qualcosa si muove. Lentamente, a fatica, ma anche la macchina dei live in Italia sta tornando a muoversi, a far spostare le persone, a far riaccendere le luci sui palchi, a tentare di metterci alle spalle questo annus horribilis.
C’è da dire che, almeno in questo primo periodo, i concerti non somiglieranno molto a quelli che eravamo abituati a frequentare, in quanto toccherà convivere ancora per un po’ con mascherine, distanziamenti ed altre limitazioni che ormai fanno parte della nostra quotidianità. E qui per la maggior parte degli artisti sorge il dilemma: pur di suonare mi adeguo e modifico (snaturo?) le mie esibizioni oppure attendo ancora che arrivi questo benedetto “liberi tutti”?
C’è anche una terza via a dire il vero, ed è quella che ha scelto Gian Maria Accusani, che non dovrebbe aver bisogno di presentazioni ma parliamo del frontman negli anni ’90 nei mitici Prozac+ e dal 2007 nei Sick Tamburo, il quale ha deciso di proseguire da solo. Nessun allarme, niente panico, i Sick Tamburo sono vivi e vegeti e pronti a tornare, sia con un nuovo disco che dal vivo, ma Gian Maria nei prossimi mesi sarà in giro per l’Italia con un incrocio tra concerto e spettacolo, Da grande faccio il musicista, nel quale ripercorre la sua ormai ultradecennale carriera.
Lo abbiamo intervistato qualche giorno fa e ci ha raccontato di più di questa nuova avventura e di come sia nata l’idea. E molto altro.
Ciao Gian Maria, prima di parlare del tuo nuovo tour mi interessava chiederti come hai passato questi ultimi ormai 18 mesi “difficili” e soprattutto, quando ormai era chiaro che non si sarebbe suonato per un anno e più, come hai accolto la notizia e come hai deciso di agire, di conseguenza?
“Ciao Alberto, allora lo scorso anno non ha suonato praticamente quasi nessuno, e come Sick Tamburo abbiamo deciso di non suonare nemmeno quest’estate, perché con il pubblico distanziato, le mascherine, ecc, non ce la siamo sentita, onestamente. Io capisco i gruppi che accettano di esibirsi in questa situazione, sia chiaro, ci sta. A me personalmente il pensiero di suonare con la gente seduta, a meno che non si tratti dell’Arena di Verona, non fa impazzire, mi pare manchi almeno metà della mia idea di concerto, per cui sì, abbiamo deciso di aspettare ancora un po’.”
E l’idea di imbarcarsi in questa nuova avventura quindi è per così dire figlia della situazione, del periodo o si tratta di qualcosa che già ti frullava in testa da un po’. E già che ci siamo come mai questo titolo?
“L’idea sinceramente ce l’ho da tempo, ma in tutta onestà non avevo mai avuto il coraggio di metterla in piedi e anzi, probabilmente senza pandemia questo coraggio non lo avrei mai avuto. È anche vero che ancora adesso l’idea di me da solo sul palco non mi entusiasma, però poi ho iniziato a ragionarci un po’ su, ed è nato questo spettacolo nel quale racconto il mio sogno che si è realizzato – e da qui il titolo – in quanto ho iniziato a suonare a sette anni e da quel giorno quando qualcuno mi chiedeva “cosa farai da grande” la risposta era sempre “da grande faccio il musicista”. Quindi racconto il mio viaggio all’interno del mondo della musica, ripercorrendo episodi più o meno famosi, dal Great Complotto a quando a diciotto anni sono finito a Londra, da quando son tornato per fare il tour manager e lavorare con Ramones, Beastie Boys, Henry Rollins, e poi ovviamente i Prozac+ e Sick Tamburo, per arrivare al giorno in cui sarò sul palco. Il tutto farcito da canzoni che hanno attinenza a ciò che sto raccontando.”
Quindi parliamo di un vero e proprio spettacolo per così dire “strutturato”…
“Assolutamente sì, c’è uno scheletro ben preciso, anche perché se no il rischio sarebbe di andare per così dire fuori tempo, e trovarti dopo due ore ad essere ancora ai Prozac, per dirti di quante cose ci sarebbero da raccontare…”
E ti sei fatto aiutare da qualcuno per una sorta di regia?
“No, ho fatto tutto da me. Lo spettacolo dura quasi due ore, suono tredici, quattordici pezzi, e poi il resto è racconto. Ovviamente ci saranno delle variazioni, qualche aneddoto cambierà da spettacolo a spettacolo. C’ho lavorato su un bel po’, sarò seduto, come il pubblico, e vorrei che diventasse come se stessi raccontato qualcosa ad un amico.”
Mi pare di capire che quindi è la tua prima volta da solo. Dopo centinaia, migliaia di date, come la stai vivendo questa attesa?
“È la mia prima assoluta da solo e la verità è che sono molto in tensione, davvero. È anche vero che nonostante non sia proprio più un esordiente, ad ogni concerto prima di salire sul palco, lo dico come lo diciamo noi, mi cago sempre sotto, ancora adesso. È proprio la mia natura. Poi quando inizio passa tutto.”
Quindi mi par di capire che questa comunque sia da considerarsi una parentesi più o meno estemporanea, e che i Sick Tamburo siano ancora la tua priorità, il tuo presente. Sai perché te lo chiedo? Mi era venuto il dubbio vedendo la copertina del singolo Il fiore per te, dove ci sei tu in primo piano e due ombre di Sick Tamburo sullo sfondo…
“La copertina di cui parli l’ho scelta perché si tratta di un disegno che ha fatto un fan e che mi aveva regalato una sera dopo uno spettacolo, e mi aveva profondamente emozionato. Questa cosa che sto facendo non ha nulla a che fare coi ST, i quali sono e rimangono la cosa più importante che ho al momento, sono il mio presente e appena si potrà tornare un po’ alla normalità sicuramente, anzi non vedo l’ora, faremo uscire un disco.”

Domanda difficile adesso: considerato che lo spettacolo segue la tua carriera e volendo trovare quattro distinti momenti, ovvero Great Complotto, Prozac+, Sick Tamburo e il presente, mi dici quattro aggettivi, quattro parole, che individuino ciascuna parte?
“Allora ti dico quattro parole, che esprimo tutto il concetto di questo racconto: sogno, in quanto è il mio sogno che si è realizzato, mondo magico che è quello in cui mi sono trovato catapultato al tempo del Great Complotto, entusiasmo e ultima cosa, che è quella che unisce un po’ tutte le precedenti è l’amore, nel senso più esteso, l’amore per tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio e che sono state l’energia per andare avanti.”
Correggimi se sbaglio, visto che ne accennavamo prima, ma io ho sempre visto i tuoi progetti, specialmente i Prozac+ e i ST, fortemente caratterizzati dal punto di vista geografico, e questo sia chiaro è un enorme complimento. Mi spiego, ho sempre avvertito forte la presenza del Friuli, e di Pordenone in particolare, in quelle band. Oltre al Great Complotto e a quella situazione magica e presumo irripetibile, parliamo di una zona decentrata, lontana dalle grandi direttrici, dai grandi centri culturali come possono essere Bologna o Milano, mentre tu hai sempre fatto base a casa a Pordenone, giusto?
“Si, diciamo che pur avendone avuto anche la possibilità ho sempre sentito forte la necessità di tornare a prendere una boccata d’aria a casa, nei posti dove sono nato e dove ancora vivo…”
Quindi non credi sarebbe stato più semplice, meno tortuosa, la strada per arrivare ad un successo, che comunque hai avuto, se fossi stato altrove?
“Credo di no, credo che il fatto di aver vissuto in una piccola città di provincia in qualche modo, specialmente in epoca pre internet — dopo di che le distanze, anche geografiche, si sono ridotte a dismisura — sia stato uno sprone, una spinta a fare di più, a fare meglio, a spingersi a livelli che altrove non avresti raggiunto perché magari non ne avresti avvertito o sentito la necessità. Quello che arrivava o che sentivi a Milano non era quello che arrivava a Pordenone, certe cose non giungevano proprio fino a lì, per cui ce le inventavamo noi. È esattamente il contrario, Pordenone è stata proprio la spinta, la voglia di creare.”
Facciamo un attimo un passo indietro, poi prometto di liberarti; mi interessa sapere che idea, che pensiero ti sei fatto, come ti sei posto, da persona assolutamente dentro, da addetto ai lavori, in merito alla protesta dei bauli in piazza Duomo, ai ritardati quando non assenti contributi al comparto musica, che parrebbe essere stato il reparto meno aiutato o considerato dal governo durante questa pandemia… ricordo mesi piuttosto burrascosi e caldi…
“Allora, molto francamente il mio pensiero in merito a questa cosa qui è molto chiaro: semplicemente mi sono reso conto guardando quello che è successo e parlando anche con quelli che lavorano ai piani alti, che siamo stati i meno considerati per un semplice cosa, triste ma vera: il comparto musica muove zero soldi, cioè ne muove tanti ma rispetto ad altri settori è irrilevante, per dire il reparto musica non veniva nemmeno accettato ai tavoli di discussione, la verità è questa. Si parla tanto di cultura ma in Italia la verità è che la cultura viene considerata molto molto meno di quanto pensiamo, proprio perché non muove le cifre di altri, è sempre lì la questione. Ed è lì il male. Uno pensa a cultura e non dovrebbe in automatico pensare al rientro economico. Purtroppo, nel 2021, ancora oggi mi fermano e se mi chiedono che lavoro fai e rispondo il musicista mi chiedono “OK, ma di mestiere vero?”. È una questione proprio culturale, siamo un paese di artisti ma la struttura e l’organizzazione che c’è dietro è davvero arretrata, e ce ne siamo accorti durante questi mesi. E lo dico con profonda tristezza…”
Il ragionamento non fa una piega, però mi par di capire che non se ne esca, siamo in una sorta di circolo vizioso, in un loop…
“Beh, in molti paesi ci sono i sindacati dei musicisti, in Francia, in Germania, in Inghilterra, da noi invece non c’è niente. Lì chi fa questo mestiere è tutelato, qui ti devi inventare, per non parlare della burocrazia, che è una cosa obsoleta ed orrenda, anche se qui non è un problema solo della musica ovviamente.”
Chiaro. La speranza è che le cose prima o poi possano iniziare a cambiare… Nel frattempo ti ringrazio della chiacchierata.
Grazie a te!
E ci vediamo prossimamente sotto un palco, intanto seduti…
E speriamo presto in piedi!
Alberto Adustini