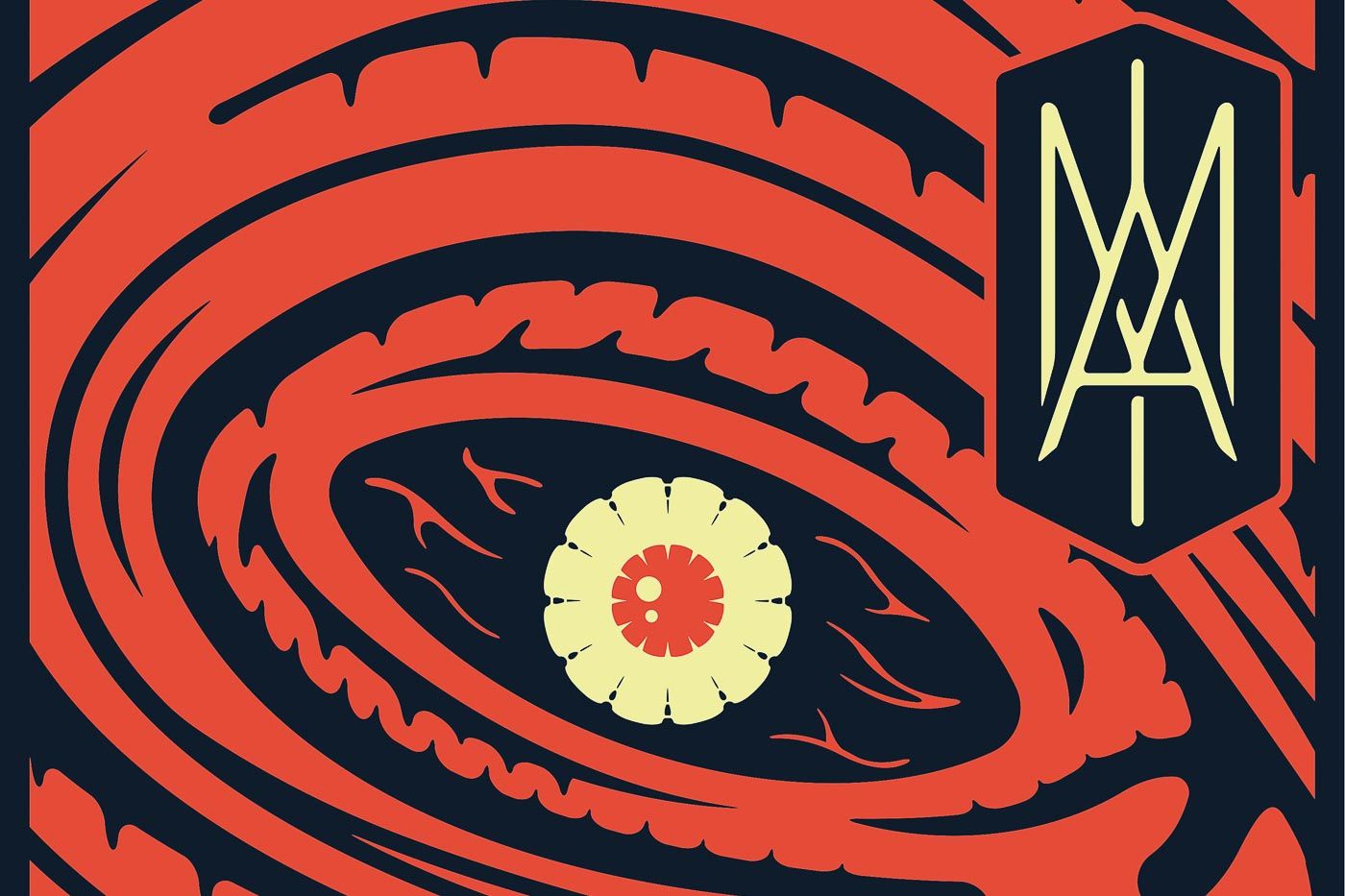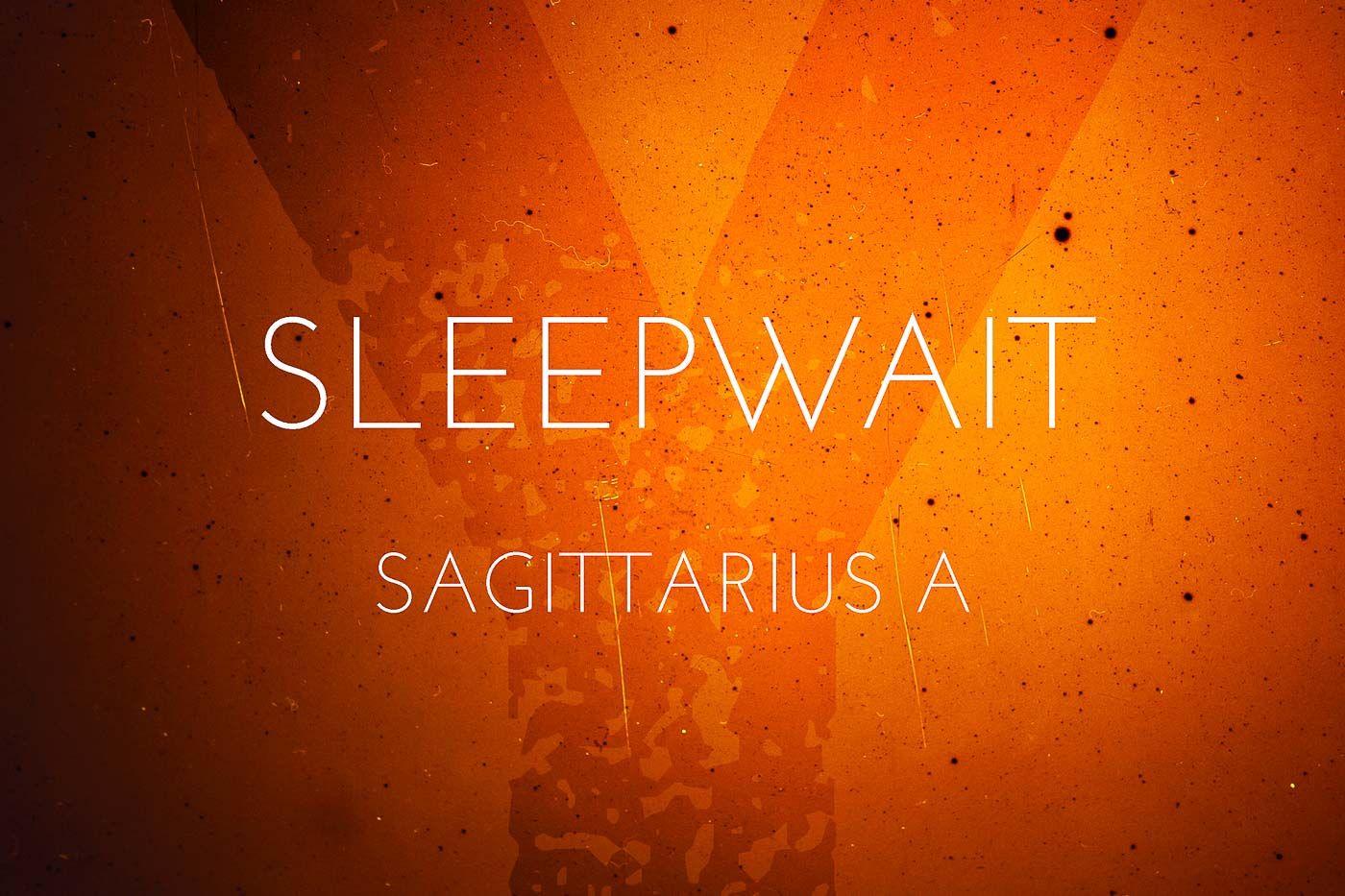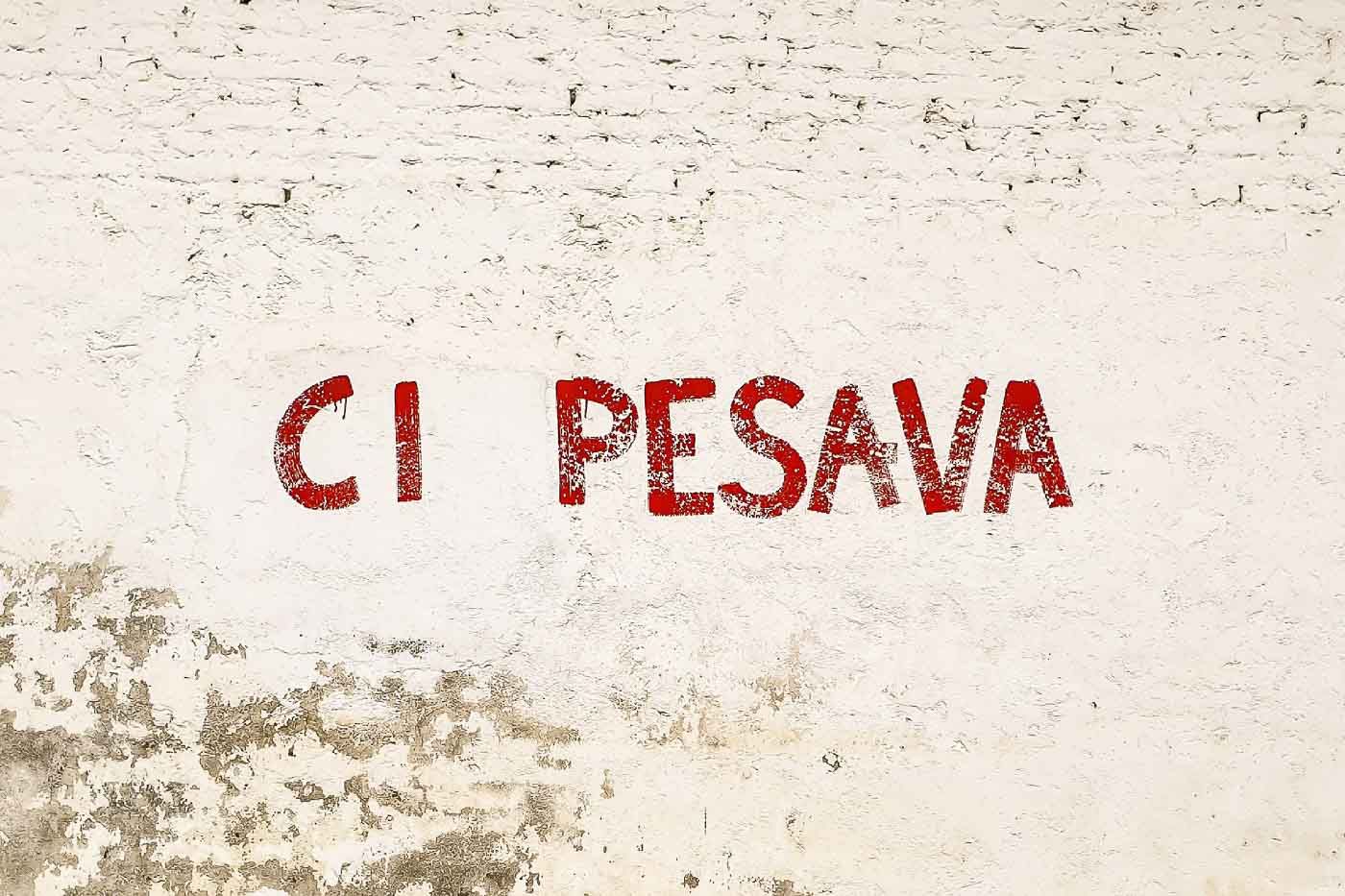Toothgrinder “I AM” (Spinefarm Records, 2019)
Mascelle serrate e denti digrignanti
La notte non porta sempre consiglio, alcune volte provoca forti attacchi di bruxismo, soprattutto in periodi stressanti o in condizioni patologiche di abuso di sostanze eccitanti (fumo, alcool, droghe, caffeina).
I Toothgrinder volevano comunicare questo con la scelta del loro nome: un metal graffiante, velenoso, virulento; un’offensiva al nostro sistema nervoso, con uno stile che ci getta in un mondo fatto di growl, batterie incalzanti e assoli allucinogeni.
Nel 2010 cinque ragazzi in una high school del New Jersey decidono di metter su una band per urlare il loro disagio generazionale, e nel giro di un anno esce il loro primo EP Turning of the Tides, seguito da altri due EP prima di arrivare alla svolta, nel 2016 con l’album Nocturnal Masquerade e nel 2017 con Phantom Amour.
I brani con cui hanno esordito sono colmi di scream e di testi duri, puro posthardcore, per subire una trasmutazione con l’avvento dell’età adulta e della consapevolezza di sé.
Come un fiume nasce dalla fonte e affronta anse tortuose e rapide improvvise prima di sfociare nel mare, questa band ha acquisito una maturità stilistica che ha permesso di sfruttare questo genere musicale non solo per comunicare rabbia e frustrazione, ma soprattutto per trasmettere una visione di cambiamento e di crescita passando gradualmente a toni più pacati, più melodici, senza però modificare la loro natura metalcore.
Questa trasformazione li ha portati alla produzione di I AM, un album complesso, composto da undici brani che sembrano ripercorrere i vari stadi della loro evoluzione.
Il frontman Justin Matthews lo ha definito come un viaggio per l’accettazione di sé, un percorso ad ostacoli, costellato di errori, di scelte sbagliate, di cattive abitudini nelle quali riversare il disprezzo e la disillusione adolescenziale.
Le intenzioni sono chiare sin dal primo brano, The Silence of a Sleeping WASP. Le doti vocali del cantante ci trasportano nella loro visione di progressive metal, fatta di growl mista a passaggi melodici delicati accompagnati da un sottofondo musicale fortemente posthardcore.
La dolcezza della voce di Justin è straziante nei brani ohmymy e My favorite Hurt, ed unisce testi intimi che parlano di solitudine, di dolore ma anche di amore. Con un timbro che, in alcuni passaggi e soprattutto nel terzo brano, scade nel pop, riprende lo stile heavy sul ritornello con assolo di chitarra a dir poco sbalorditivo: una bivalenza che ricorda molto Corey Taylor (Slipknot e Stone Sour), unito ad uno stile molto Deftones.
L’album continua alternando pezzi melodici a brani dalle sonorità coriacee. Una montagna russa di emozioni dove si passa dalle lacrime al pogo sanguinolento, come per The New Punk Rock e too soft for the scene, TOO MEAN FOR THE GREEN, pezzi ritmicamente metalcore, caratterizzati da growl e headbanging a volontà.
Gli ultimi due brani (Can Ü Live Today? e The Fire of June) sono un ritorno alle loro origini, un progressive metal che sfocia nel nu metal, come per ribadire il forte attaccamento allo stile con cui sono nati. Si cresce, si cambia, ma quel che siamo stati non ci abbandona mai.
I AM è l’ultimo pezzo dell’album. Scelta tattica del gruppo, forse, visto che in esso risiede il senso più profondo di tutto il loro lavoro. Il testo incarna un mantra, “io sono…”, che spinge a far pace con il passato, con gli errori commessi; porta a concedere un’ulteriore possibilità a noi stessi, imparando dalle debolezze a essere più forti. Quello di cui abbiamo bisogno risiede già dentro noi, dobbiamo solo trovare un modo per riscoprirlo. Tutti possiamo raggiungere il riscatto emotivo che meritiamo solo attraverso l’amore (Love will conquer all).
Attraverso uno stile musicale notevole e mutevole l’album trabocca di tutte le emozioni umanamente concepibili, una catarsi personale coinvolgente che dona speranza e sano metalcore spaccatimpani.
Toothgrinder
I AM
Spinefarm Records, 2019
Marta Annesi