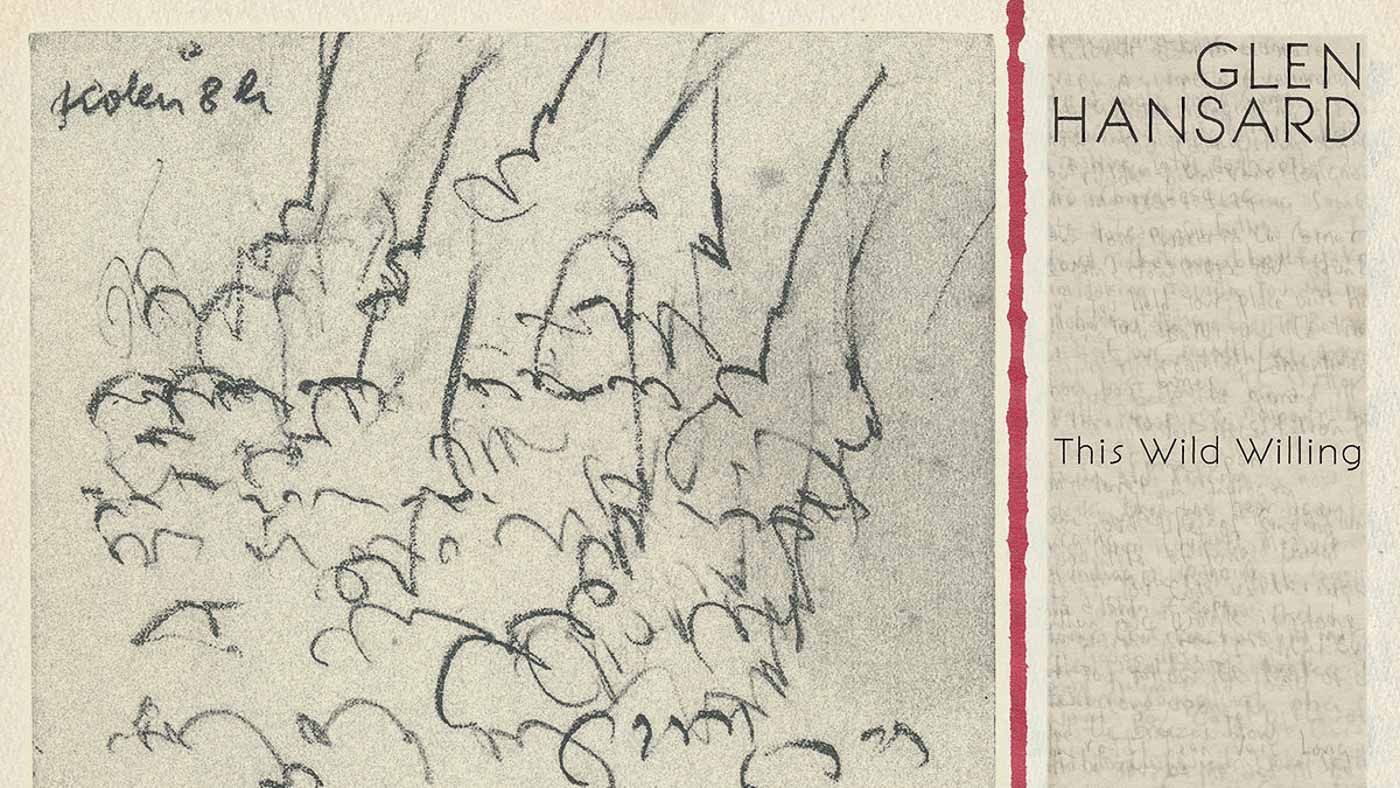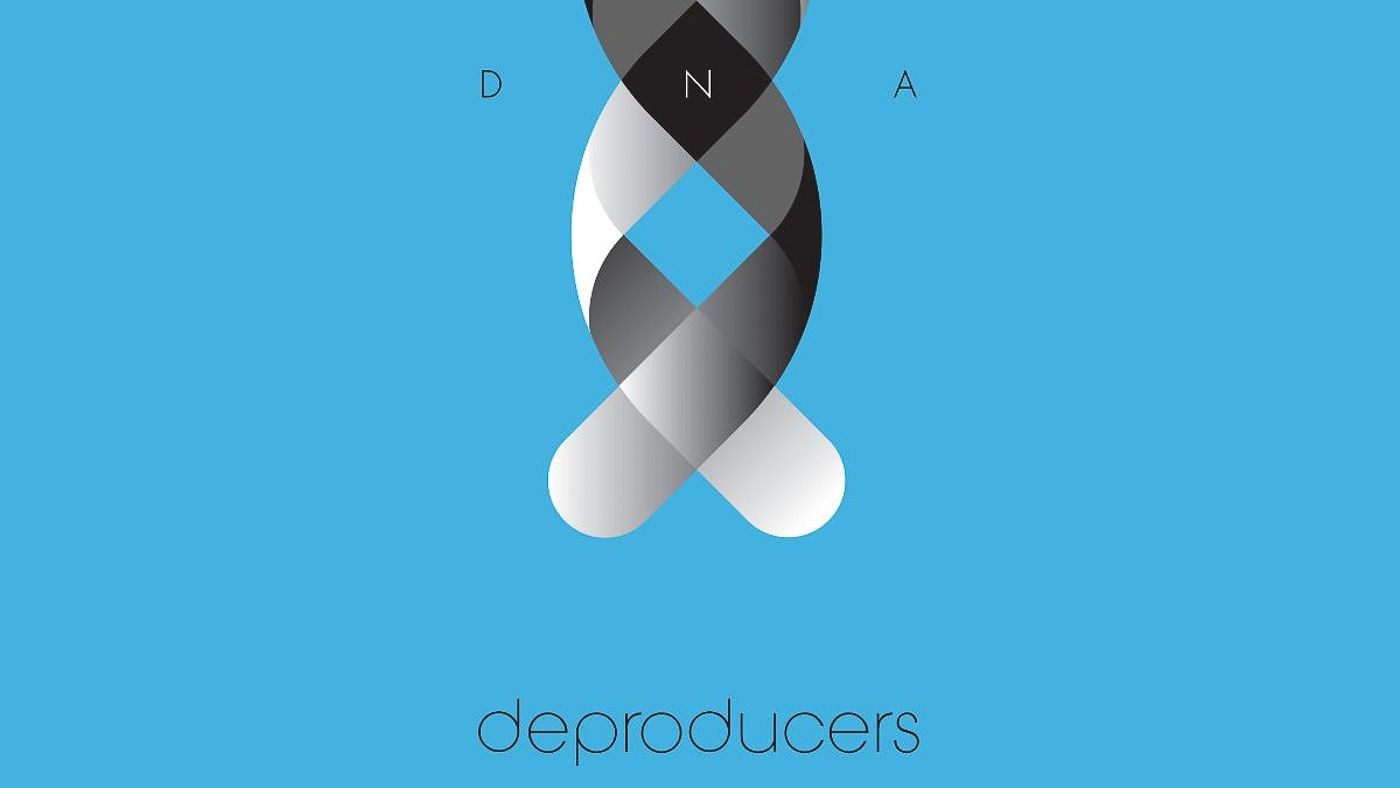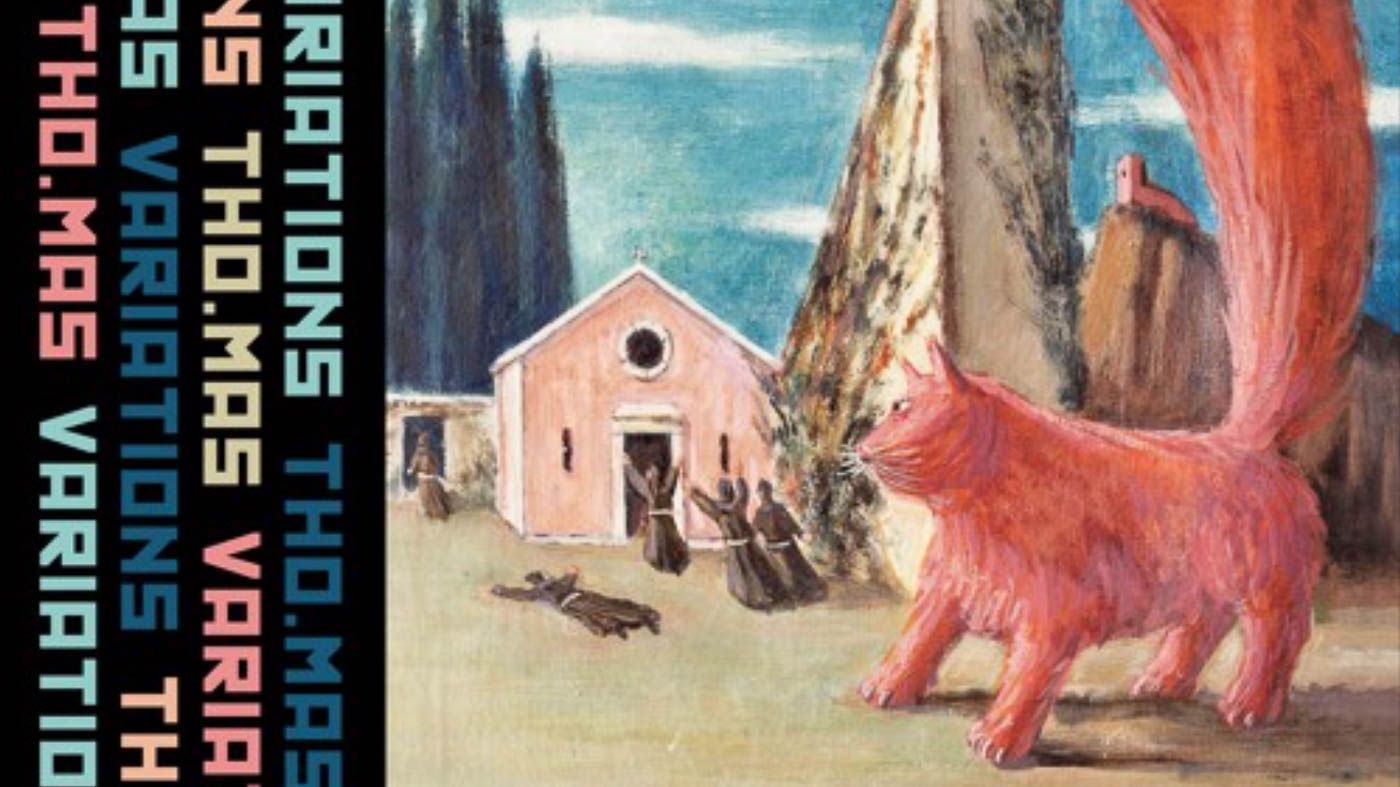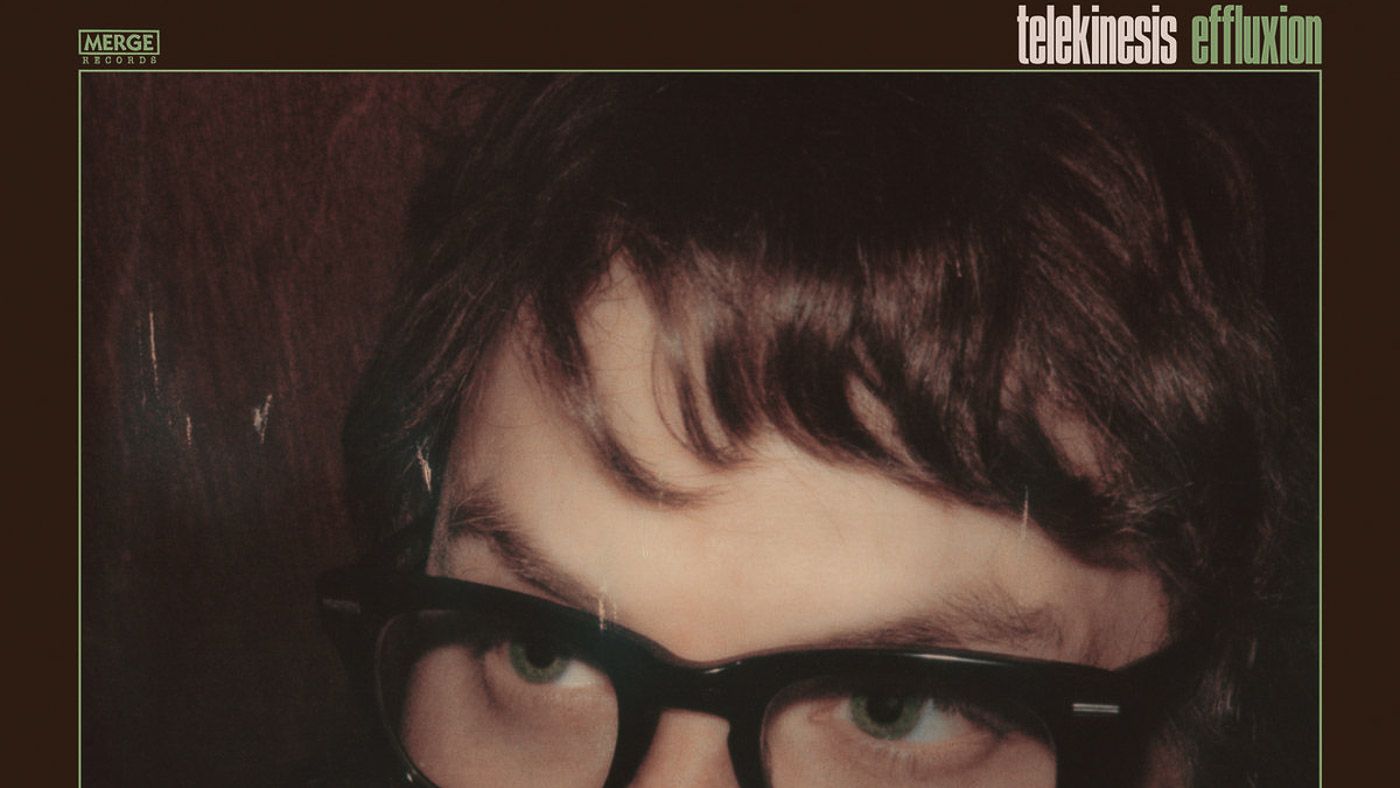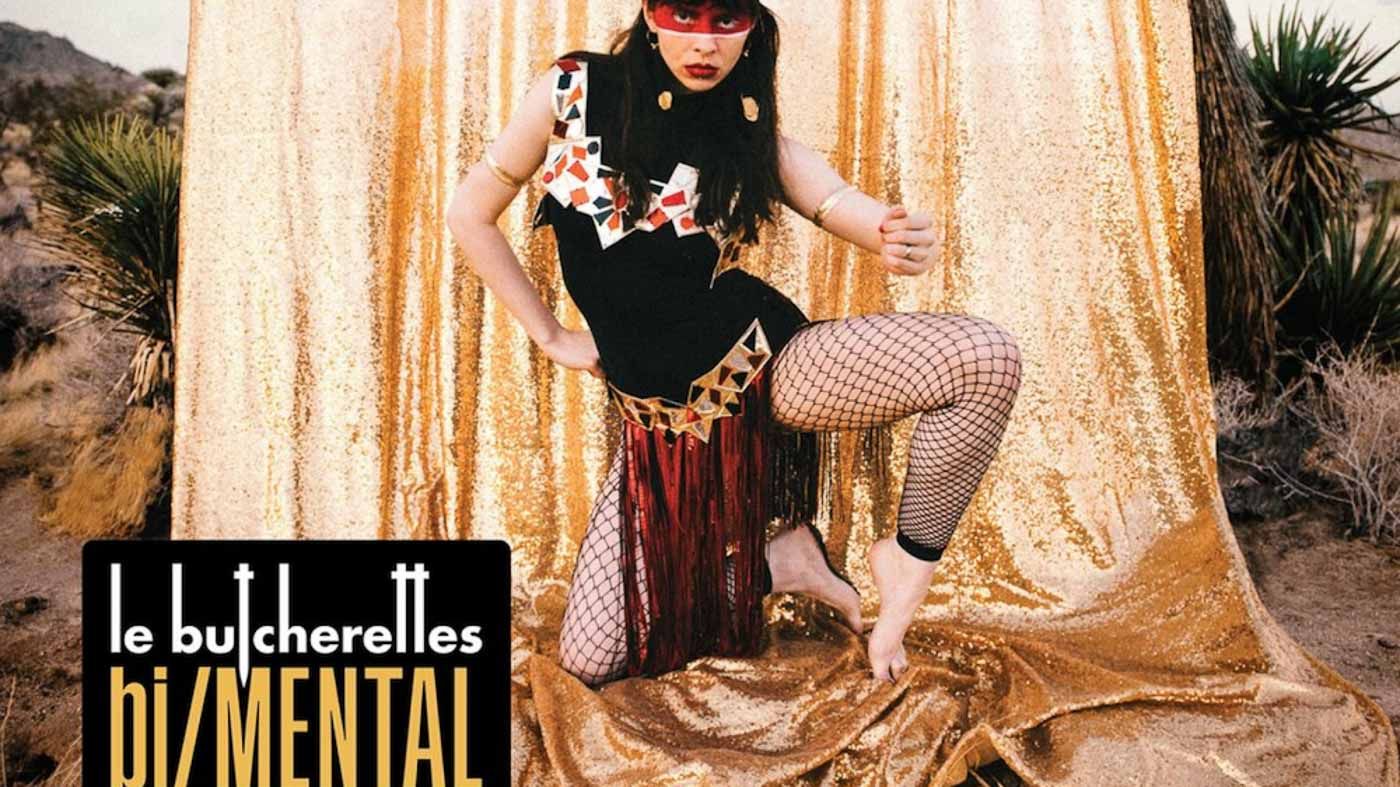Mac DeMarco “Here Comes the Cowboy” (Mac’s Record Label, 2019)
Mac DeMarco è un tipo strano, altrimenti non si spiega perché mai un canadese dovrebbe realizzare un intero disco dedicandolo ai cowboy. Certo, cowboy bizzarri, come lui, fumettistici, ma pur sempre cowboy. Proprio lui, quello che di più lontano dall’immagine hollywoodiana del vaccaro con pistola, cappello a falda larga e speroni, possiamo immaginare. Probabilmente i cowboy che passano le giornate a bere nei saloon avrebbero voluto prederlo a calci nel sedere, uno come DeMarco: Mac è uno da t-shirt e cappello da baseball, da maglioni del nonno e da salopette. Non è un macho, non si prende sul serio e, soprattutto, non usa artiglieria pesante. Ma, cosa più importante, non salverà la situazione come ogni buon cowboy che si rispetti: la guarderà andare a rotoli e poi ci scherzerà su. Ed è per questo che lo amiamo così tanto.
Here Comes The Cowboy è il suo quarto, ed insolito, album, che arriva cinque anni dopo Salad Days, il lavoro che lo consacrò a figura iconica della musica indie internazionale, e due anni dopo This Old Dog, dedicato alla relazione difficile con il padre. Questo lavoro è il primo prodotto dall’etichetta che lui stesso ha fondato, la Mac’s Record Label. Tutto fatto in casa, insomma, come confermato anche dalla scelta di suonare quasi tutti gli strumenti per conto proprio, ad eccezione delle tastiere affidate in certi casi ad Alan Meen, e avvalendosi soltanto dell’aiuto del fonico Joe Santarpia. Il fatto che DeMarco abbia deciso di auto-prodursi un album merita una riflessione: probabilmente dietro c’è il bisogno di avere maggiore libertà, la possibilità di essere veramente se stesso, di fare un po’ come vuole. Sacrosanto. E infatti Here Comes the Cowboy si spinge fino ai confini dell’iperuranio.
Solo per darvi la dimensione di quello che succede, la prima traccia, quella che dà il titolo all’album parte con una chitarra, che fa pensare al classico cazzeggio pre registrazione per scaldarsi un po’ le dita, ed è composta da un solo unico verso, ripetuto all’infinito: “Here comes the cowboy”. Eppure, nonostante queste premesse che potrebbero far presagire il peggio, il pezzo è caratterizzato da un perverso magnetismo. I suoi cowboys infatti non possono essere altro che personaggi strambi, niente di eroico, per carità, ma qualcosa che conforta in una società che ha sempre più difficoltà ad ammettere le proprie debolezze.
Quasi tutti i pezzi sono percorsi da una vena malinconica. Su questa atmosfera c’è Nobody, un pezzo laconico, tra i migliori del disco, una marmellata di suoni in stile californiano.
Preoccupied, invece, ci porta su un piano diverso, meno giocoso e meno dolce, più preoccupato, appunto. Non è difficile immaginarselo, Mac, mentre guarda pensoso, fuori dalla finestra. Tra le parti più interessanti del pezzo c’è la base con il cinguettio degli uccellini, che contribuiscono a dare consistenza al mondo surreale e sgangherato che DeMarco ci racconta; il testo è un blues disincantato, e sembra quasi criticare una cultura trumpiana in cui le menti sono “aperte” ma “piene di cazzate”.
Proprio l’aspetto dei testi è interessante in questo disco: molto più asciutti, a volte pervasi da un vero e proprio minimalismo linguistico, ma sempre con valutazioni sardoniche sul sogno americano. Come in All Of Our Yesterday, pezzo sarcastico che esplicita il concetto che molte delle cose migliori del nostro passato sono scomparse e non torneranno. Anche per questo motivo, è evidente che DeMarco è cresciuto. Questo è senza dubbio il suo disco più autentico e sporco. Se è vero, come aveva dichiarato in qualche intervista, che Salad Day era stato scritto in camera da letto, questo Here Comes The Cowboy è assolutamente stato composto in garage, o in una soffitta polverosa e invasa dalla luce del sole, che gli ha permesso di vedere meglio ogni singolo pulviscolo.
Quando arriva Choo Choo mi chiedo se sia uno scherzo. Forse sì. Su una base funk il fischio del treno fa da contraltare al falsetto di DeMarco, che ancora oggi si dimostra un artista accessibile e mai troppo serio, uno che fa musica – apparentemente – ingenua e che sembra immune dall’invadenza del mondo reale. È come se si fosse creato una bolla per proteggersi dalla tristezza di quello che succede. Forse, però, qualcosa sta cambiando. Su Little Dogs March, canta “spero che ti sia divertito, tutti quei giorni sono finiti ora”.
L’ultima traccia, Baby Bye Bye, è la più assurda di un disco abbastanza assurdo, ma è anche uno dei pezzi più memorabili. Non voglio rovinare la sorpresa a nessuno, quindi dirò solo che dentro ci si può trovare una chitarra slide, un treno che parte, una voce che parla giapponese e qualche sonorità funk.
Il bello di Mac è questo suo essere diventato oggetto di una sorta di strano culto, ovunque accolto come una grande star, un’icona insolita e sbilenca, e allo stesso tempo di fregarsene totalmente di quello che viene prodotto oggi nel mondo della musica. Quello che appare evidente da questo disco è che Mac DeMarco stia cambiando, forse sta diventando grande, chissà.
Here Comes The Cowboy sembra testimoniare il desiderio di trovare una nuova strada. Si tratta essenzialmente di un album più nudo rispetto ai precedenti, a partire dagli arrangiamenti, spesso composti da una chitarra, un piano e poco altro, fino ad arrivare ai testi.
Buono, ma a volte – ad eccezione di qualche pezzo – ci si ritrova a desiderare qualcosa di un po’ più divertente, un po’ più vivace, un po’ più DeMarco.
Mac DeMarco
Here Comes the Cowboy
Mac’s Record Label, 2019
Daniela Fabbri