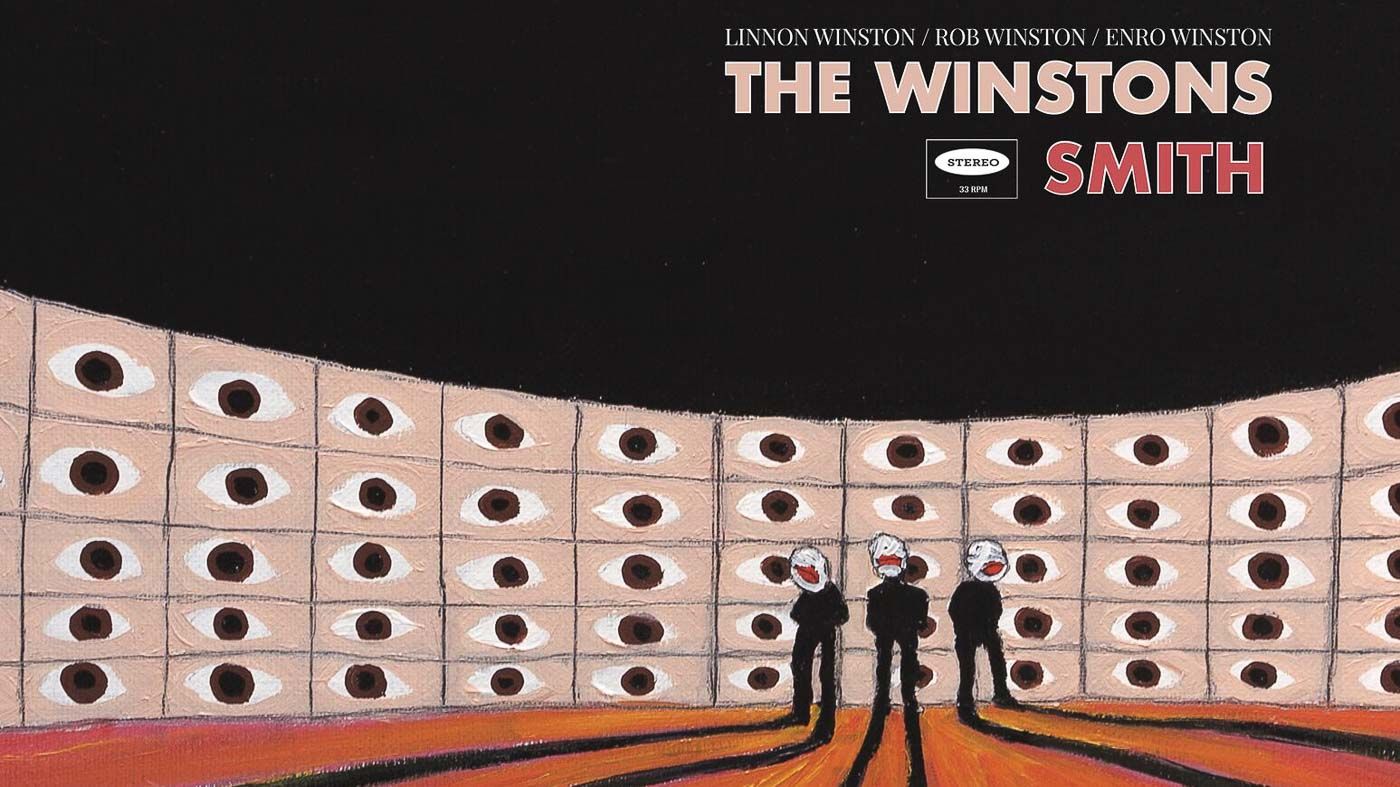Grayscale “Nella Vita” (Fearless Records, 2019)
Dipinto emotivo in scala di grigi
L’estate sta volgendo al termine, portandosi via la tipica voglia di far baldoria, inneggiando ad una vita gioiosa e senza pensieri.
Le giornate si accorciano, l’inverno è alle porte e con esso il malessere tipico del ritorno alla vita quotidiana: clima perfetto per l’uscita del nuovo disco dei Grayscale, che tornano con Nella Vita, titolo tutto italiano per questo quintetto pop punk americano.
Musicalmente nati nel 2011, a distanza di quattro anni esce il loro primo EP, Change, ma l’anno del debutto ufficiale è senza dubbio il 2017, con l’album Adornement per Fearless Recording.
I Grayscale sono una miscela di emozione pura e grezza, con elementi del rock alternativo, radici punk ben assestate, e una combinazione di hip hop moderno.
Attraverso la musica ci restituiscono un’immagine emotiva in scala di grigi, iniziando dal nero della depressione, passando per il grigio della consapevolezza e arrivando al bianco candido della redenzione di sé stessi.
I Grayscale sono reali come le nubi, come la pioggia.
Sono reali come la sofferenza, come la perdita.
Parlano di morte, di amore tossico, di depressione, di droga e di sesso.
Con Nella Vita realizzano un album molto pop rock punk, con il quale riescono a comunicare dolore e disperazione con un ritmo orecchiabile e ritornelli indie. Canticchiando queste canzoni si finisce con l’empatizzare con le tematiche tragiche descritte nei testi.
La morte conclamata, in In Violet, primo singolo che accompagna l’uscita del disco, è un brano molto personale, come ammette il frontman del gruppo, il quale, durante un periodo tormentato, ha pensato al suo funerale dove avrebbe voluto che tutti i presenti fossero vestiti di viola, cantando e sorridendo alla vita. Fa riflettere su come noi occidentali consideriamo la morte come fine del percorso, un evento negativo. Con questo pezzo invece, i Grayscale ci propongono una nuova chiave di lettura, un’interpretazione della morte non come l’epilogo, ma piuttosto come un’esperienza di rinascita e un presupposto per gioire della vita stessa che è stata.
L’insieme di circostanze complesse che ci propina la vita prosegue in Painkiller Weather, dove si affronta una complicata storia di amore e droga, arduo conflitto amoroso tra sentimento e dipendenza. Questo pezzo descrive quanto sia penoso e complicato essere impotente di fronte alla distruzione pacata della propria amata e quanto questo conduca alla disintegrazione di sé stessi.
“Temptations won, yeah, they always won” – neanche l’amore può nulla davanti all’assuefazione dal eroina.
La tematica dell’amore malato è toccata anche in Baby Blue, dove viene decantato un sentimento depredato dall’oscurità intensa della malinconia che spazza via tutte le emozioni. Tutto intorno è annebbiato da un disagio talmente radicato che rende vuota e insignificante ogni sensazione.
I loro riff pop punk descrivono in modo schietto la depressione e la solitudine in Old friends, una ritmata ballata che colpisce nel profondo. Tutti noi ci siamo sentiti sbagliati, privi di importanza e senza futuro almeno una volta: indossare una maschera sorridente quando l’anima invece sta cadendo lentamente a pezzi, quando vorresti solo bussare alla porta di qualcuno sotto la pioggia per parlare, quando l’unico modo che hai per uscirne è confidarti e invece rimani solo, seduto sul tuo letto, colmo di odio verso te stesso.
Nella Vita è un viaggio catartico, una collezione di brani che rappresentano una cronaca di vita, di esperienze dei componenti del quintetto, con cui ci accompagnano nella scoperta della rinascita. Ascoltare questo album è esplorare la caverna umida e cupa che è in noi, il posto più nascosto che celiamo al mondo, entrare nelle viscere di noi stessi e riuscire ad uscirne più forti di prima.
Come scrive Chuck Palahniuk nel suo romanzo Fight Club “È solo dopo che hai perso tutto che sei libero di fare qualsiasi cosa”: solo arrivando a toccare il fondo possiamo darci la spinta per risalire, solo entrando a contatto con la solitudine e la disperazione possiamo tornare a risplendere.
Grayscale
Nella Vita
Fearless Records, 2019
Marta Annesi