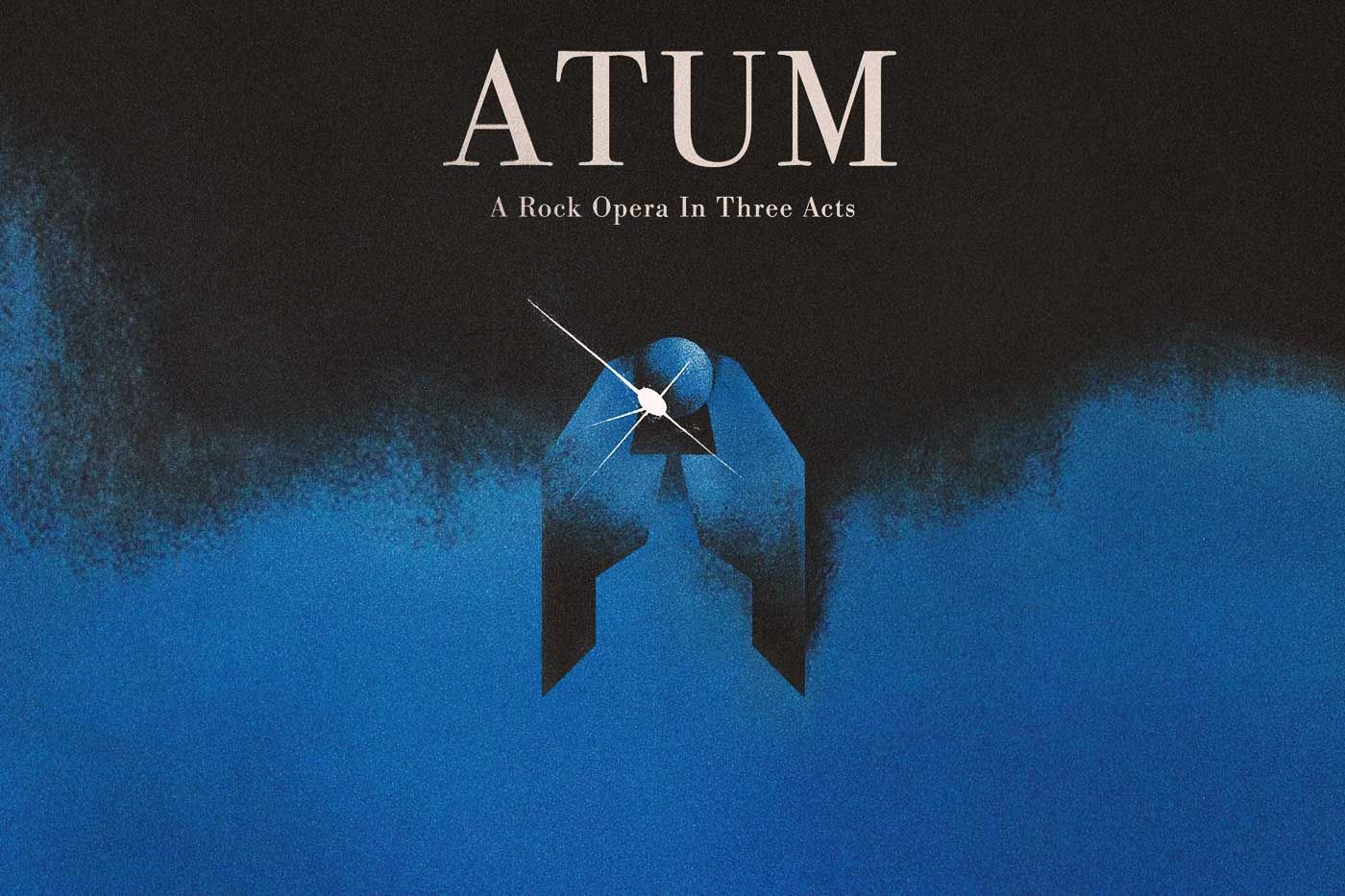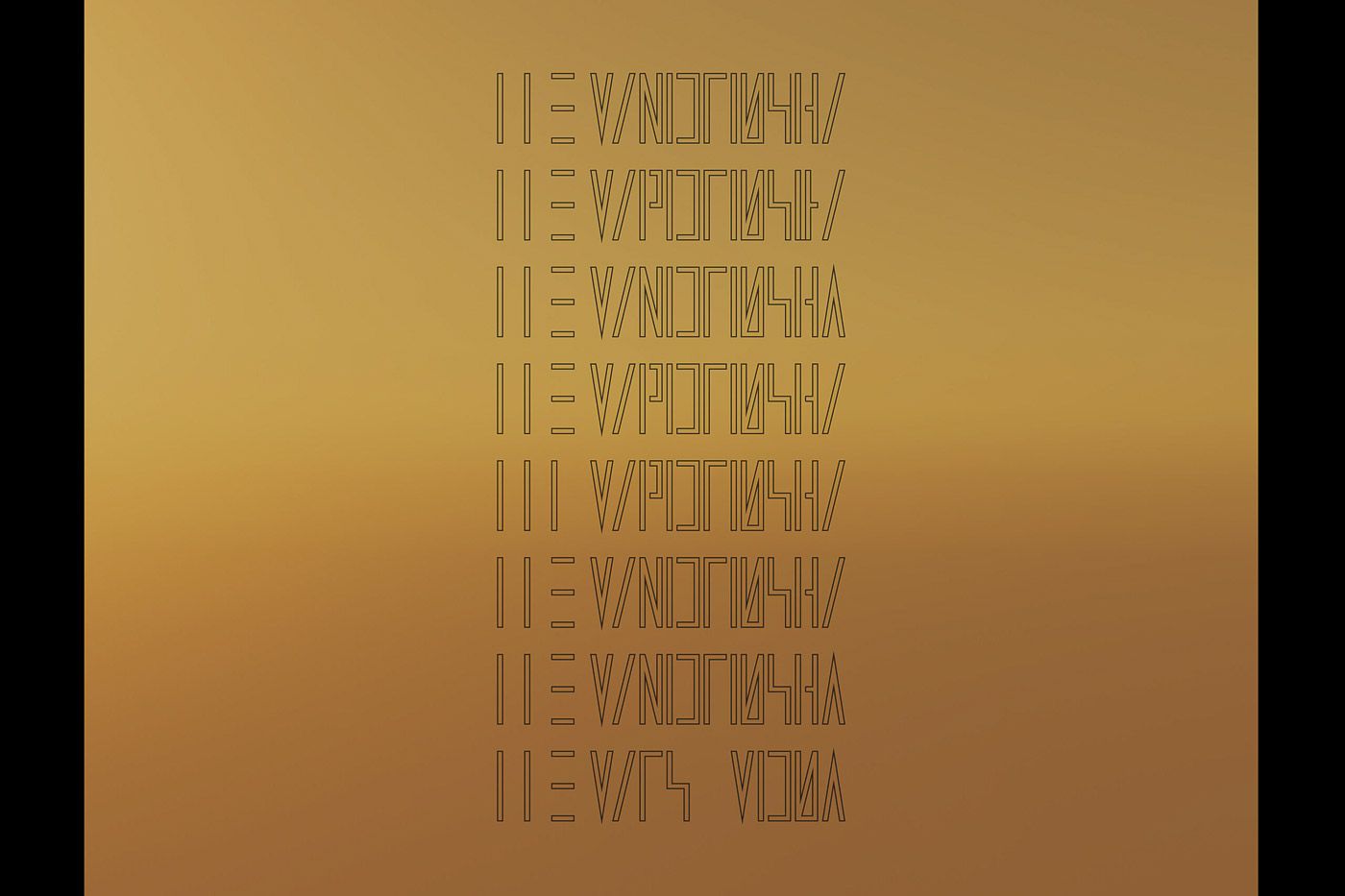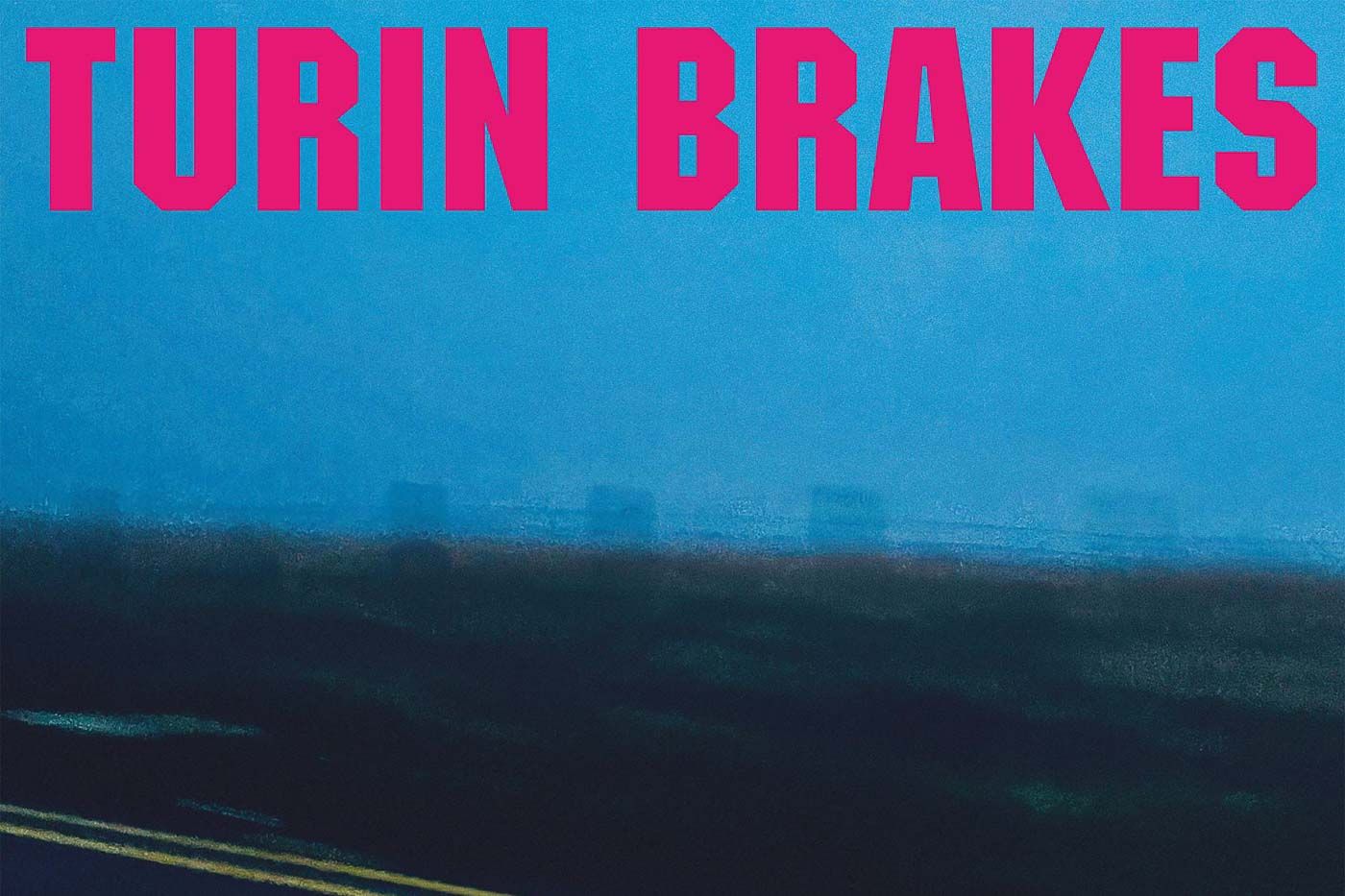Ho ascoltato questo disco una ventina di volte.
In cuffia, come da prassi, con aria da consumato sommelier, a cercar profumi e angoli nascosti.
Mentre lavoro, per stupirmi di quante volte il sopracciglio destro si potesse alzare, in totale distrazione.
Sdraiato in un prato, in solitudine, da pastorello dell’Arcadia.
Poi mi sono illuminato. Avevo un piano. E una sera libera.
Stumpwork, questo il titolo del secondo album dei Dry Cleaning, merita una serata tutta sua, un viaggio vero veramente, lui, io e una strada. Una statale verso le montagne, dove posso fermarmi e scrivere, dove ci sia buio e ci siano chilometri facili, dove posso guidare in automatico e intanto perdermi nelle note e nelle parole di Florence Shaw, perché, sono sicuro, proprio nei testi sta la chiave di lettura di questo album.
Perché è un disco fatto di solitudini, di spazi chiusi, di viaggi distratti, di pensieri nati seguendo goccioline di pioggia che scappano su finestrini. È un monumentale flusso di coscienza, sembrano mille pensieri scritti velocemente su post-it e poi lanciati in aria. Non c’è un ordine, non c’è un metodo, c’è solo una forma, uno stile, un messaggio di fondo.
Si parta, dunque. Scriverò come fossi intrappolato nei titoli di testa Lost Highway di Lynch.
L’album inizia freddo, gelido, ritmo che sa di macchina industriale. Anna Calls From the Arctic sembra il risveglio da un letargo mentale (o reale), è costruito su un crescendo, su cui si affollano pensieri rapidi, banali, a volte singole parole. È un gioco a evocare, ed è una pena godere dell’arrivo di una scarpiera, unico sollievo della giornata. Tutti i brani avranno questo disegno di fondo: nel disastro post-pandemico e post-industriale, il sollievo è effimero e materiale. Anche i pensieri che portano serenità, nati in ascensore mentre si esce di casa, sono di una superficialità imbarazzante. Piccole gioie, mentre l’ascensore precipita, a nostra insaputa.
Salva chi canta e salva chi ascolta una sana dose di cinismo, di intelligente distacco e di caustica visione. I Dry Cleaning nel pezzo che apre il disco sembrano più morbidi ed eleganti. Così sarà lungo tutto l’album.
Gary Ashby, terzo pezzo in tracklist, era la tartaruga di famiglia. Scappata durante il lockdown, dove, non si sa, come, non è dato saperlo. Ma perdere un animale come Gary non è da tutti, considerando che si era tutti a casa. Brani come l’orecchiabile Kwenchy Kups, al limite della schizofrenia, sembrano una degustazione di parole e ricordi, così come la seguente Driver’s Story.
La chitarra di Tom Dowse si lancia nel funky in Hot Penny Day, mentre viene affrontato il tema amoroso per la prima volta. La perfida metafora qui sta nell’accostare i rapporti umani al penny day, tradizione antichissima del South Devon, dove le famiglie ricche si divertivano a lanciare dalle finestre monete arroventate. Lo spasso nell’osservare i poveracci che si ammassavano ustionandosi le mani pare fosse ineguagliabile. Così sarà l’amore? Chi può dirlo. Intento si tratta si spazi vuoti e di conti correnti a rischio. E galleggiamo ancora sui temi della superficialità e della solitudine.
Stumpwork, title track da metà tracklist, entra sottopelle con un ritmo lento e cadenzato, un elegante dialogo tra sezione ritmiche e chitarre, una Shaw che quasi canta e una serie di immagini evocate senza filo logico, sembrano incipit di dialogo, approcci da aperitivo, fotogrammi di un cortometraggio in bianco e nero, pezzi di sogno che riemergono tornando a letto.
E mentre guido sento musica e parole sempre più intrecciate alla notte, ai chilometri. Anche se non riescono a descrivere qualcosa mettendolo a fuoco, in bocca si sente un gusto preciso, nelle orecchie ho la batteria di Nick Buxton, nel diaframma il basso di Lewis Maynard, mentre le parole delle canzoni, come piccole magie, evocano ricordi, scene, fantasmagorie.
No Decent Shoes for Rain è un picco altissimo. Forse la parte in cui i Dry Cleaning trovano davvero l’insieme perfetto e pretendono tutta l’attenzione dell’ascoltatore. L’amore ai tempi dello shopping compulsivo, delle relazioni via webcam in cui è più facile vedere il culo di qualcuno prima della bocca. Lockdown senza tempo, di nuovo, autoindotti, permanenti, elevati da riff sporchi, lo-fi, slow-core.
E di nuovo la superficialità in Don’t Press Me, in cui un mouse da gioco è questione di litigio. Il tutto rinchiuso in 1’50’’ in cui sembrano scendere in campo i Sonic Youth al completo.
Io guido, ma inizio ad avere un sorriso di traverso dipinto in faccia.
Micotico. Sporco. Etereo. Un basso con note lunghe e presenti in Conservative Hell, il cui titolo è programmatico. Liberty Log è un altro piccolo capolavoro. Siamo di nuovo in una stanza, siamo di nuovo alla solitudine. Qui però parole e musica si rincorrono, prima in linea retta, poi in circolo che diventa presto una trappola, un loop, di immagini e di note. È una meta-canzone che canta con un trucco da poco del registro delle libertà, che non esiste, che non c’è, che non vogliamo, che non meritiamo. Il tutto strizzando l’occhiolino ai Radiohead.
E tutto termina con un colpo di scena: Icebergs chiude l’album, che a sua volta ci lascia un messaggio (quasi) di speranza:
“For a happy and exciting life
Locally, nationwide or worldwide
Stay interested in the world around you
Keep the curiosity of a child if you can
Resuscitator”
“Mo’ me lo segno”, aspetta che accosto.
Finiti i lockdown rischiamo comunque di “vedere prima il culo di una bocca” e di ritrovarci chiusi in casa e/o in noi stessi. Collezioniamo viaggi senza passione, abbiamo reso lo shopping una terapia. L’immagine che abbiamo di noi, una volta usciti dalle nostre caverne, è distorta. Così questo è un disco di disequilibri, storto e sghembo, con una dialettica interna tra tappeto sonoro e il recitato. È una lunga poesia musicata, uno sprechgesang e un responso di sibilla, impresso su instax mischiate a caso.
Sono innamorato di Florence Shaw, delle sue fricative e dentali, al limite dell’ASMR. Mi ha fulminato con parole legate in analogie. I Dry Cleaning mi hanno trascinato nella buca del Bianconiglio, galleria laterale, dove un’Alice è chiusa in una stanza davanti a una webcam e il cappellaio compra online bustine di tè.
Un album da ascoltare sempre. Che poi è il valore vero di un album che merita: il ritornarci, o il volerci ritornare. Come un buon libro, come un posto che ci stimola.
Ecco. Forse è lo stimolo il valore aggiunto in questo lavoro. Davvero eccezionale.
Il mio premio è un cielo stellato come quelli da lockdown.
Fa fresco.
Perché ho smesso di fumare?
Torno, vediamo se verso casa questo album cambia senso anche lui.
Dry Cleaning
Stumpwork
4AD
Andrea Riscossa