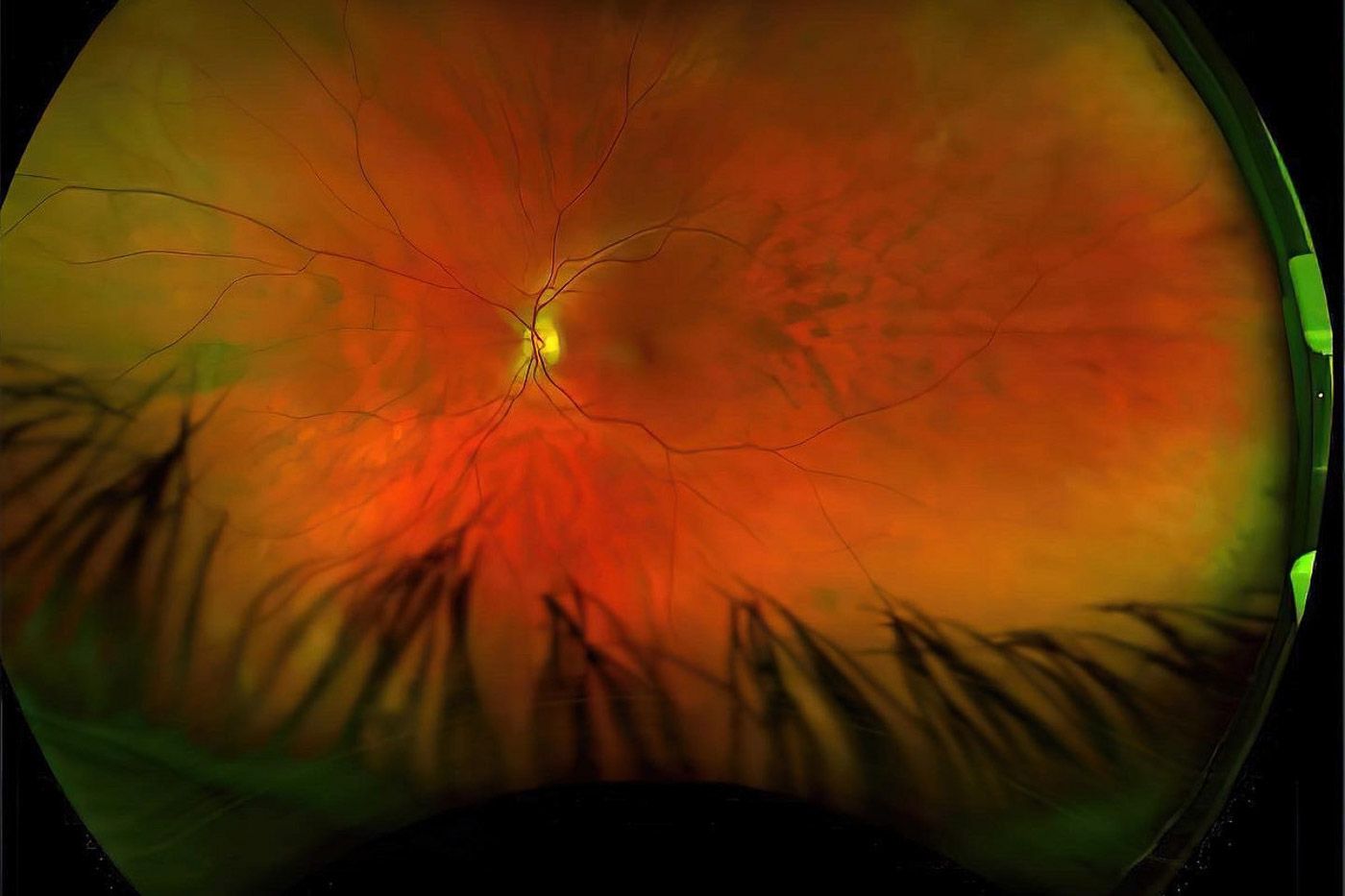Death Cab for Cutie “Asphalt Meadows” (Atlantic Records, 2022)
I Death Cab for Cutie tornano nel loro venticinquesimo anno di attività con il decimo album Asphalt Meadows.
Il disco, scritto in periodo pandemico, è il risultato del lavoro solitario dei singoli musicisti che si ritrovano isolati a provare e riprovare le tracce fino ad arrivare al magico momento del ritrovarsi per registrare la stesura finale dell’opera, che viene descritta come “la nostra prova più affiatata da molto tempo a questa parte”.
Ben Gibbard, frontman della band, è lo stesso di sempre: la voce, inalterata, si mescola sempreverde e inconfondibile tra arpeggi, synth, suoni curati a livelli maniacale.
Gibbard, nonostante veterano del genere emo e un po’ nerd di cui i Death Cab sono stati pionieri in quel Pacific North West reduce dall’ondata del grunge degli anni ’90, non rinuncia a studiare nuovi suoni e melodie, in un mondo dove si pensa che ogni anfratto del suono sia già stato scoperto e finito.
L’album si apre con I Don’t Know How I Survive, brano che, nonostante l’andamento ridondante e pacato del main riff iniziale, descrive una scena di vita quotidiana molto comune per tanti di noi: un attacco di panico irrequieto, “Pacing across the room while she’s asleep / Tears raining down your cheeks / You’re trying to hold on.”
Il ritornello suggerisce la costante risposta di chi riesce a controllare questo angosciante stato d’animo e fisico, per cui ogni volta ci si rende conto come inconsapevolmente si sia sopravvissuti.
Proseguiamo con Roman Candles (uno tra i primi singoli estratti), che ricalca i passi del tipico brano emo, dove l’evidenza della realtà prende il sopravvento su aspettative e idee più astratte, dove l’amore, che viene solitamente mitizzato per essere perfetto ed eterno, si ritrova invece su un pianeta morente. È su questa desolazione che i Death Cab ci insegnano a lasciare andare tutto ciò che si è sempre cercato di trattenere.
Il disco spazia da sonorità indie pop al post punk della bellissima I Miss Strangers, fino al post-rock di Foxglove Through The Clearcut; non mancano brani in cui viene usato un tappeto di synth, che per chi conosce bene Gibbard, si riconosce la maestria dei giusti incastri dovuti alla poliedricità dell’artista maturata nel side project Postal Service.
Asphalt Meadows è la riconferma della band, una nuova tacchetta nella loro già conclamata carriera, e forse qualcosa di ancora più perfetto e raffinato rispetto agli ultimi due album pubblicati.
Mentre ascoltiamo questo disco, non possiamo non immaginarci un Seth Cohen (co protagonista nella fortunatissima serie O.C.), steso sul letto della sua dependance, a gustarsi ad occhi chiusi il nuovo album della sua band preferita.
Death Cab for Cutie
Asphalt Meadows
Atlantic Records
Roberto Mazza Antonov