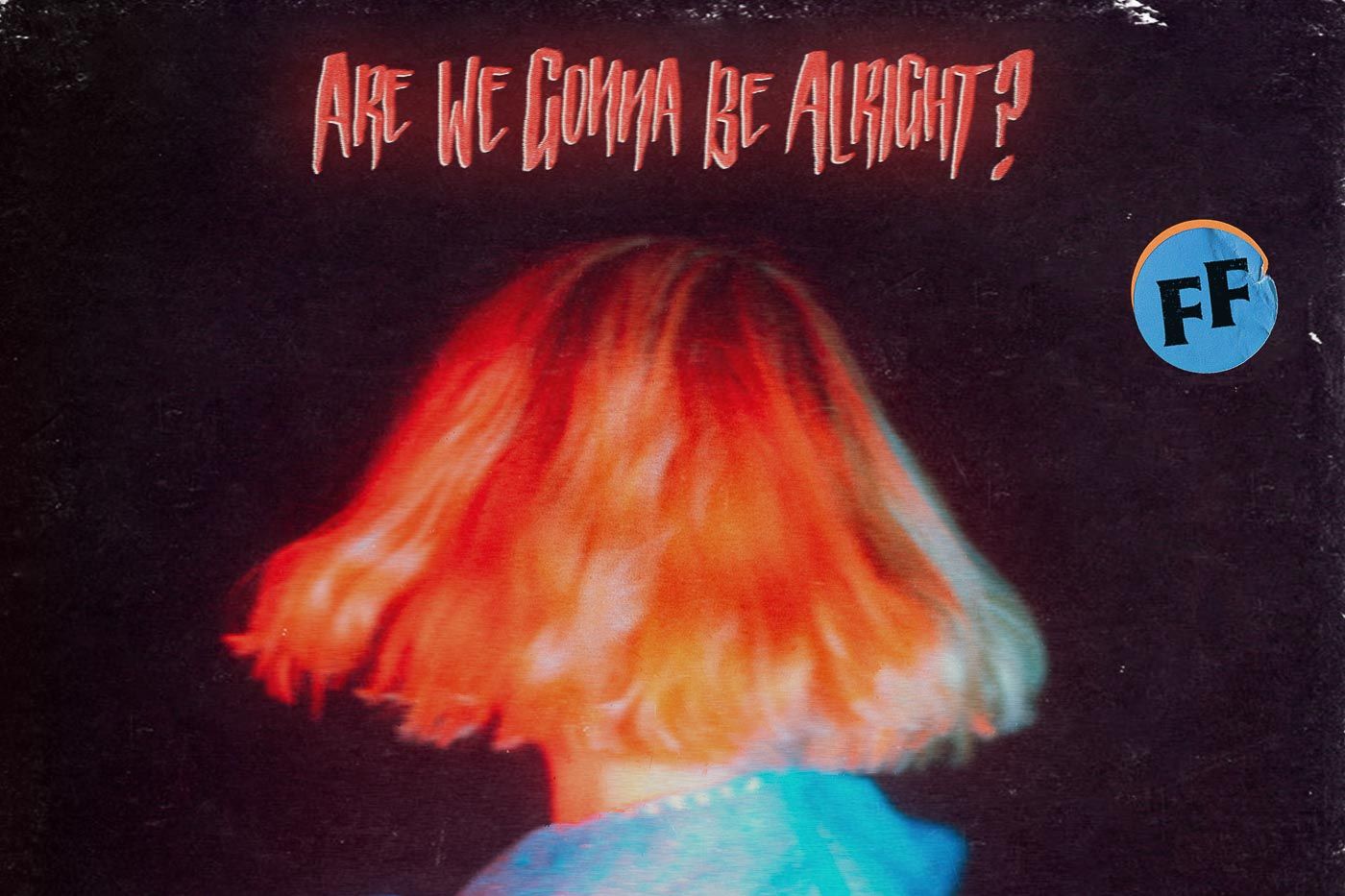Naftalina “Microgrammi di Dolore” (Supercharger Records, 2022)
Quando hai 20 anni credi di sapere tutto, dopo i 30 l’unica cosa che sai è di non sapere un benemerito cazzo.
Quello che era chiaro e limpido è spazzato via dall’uragano della vita.
E noi a 20 anni eravamo dei cazzoni, convintissimi di avere la verità in pugno, ce ne fregavamo altamente dei consigli gentili e ci rintanavamo nelle nostre compagnie, gente come noi che cercava le risposte ad ogni domanda nella musica.
Irriverenti, scontrosi, alle volte stronzi, il mondo non faceva paura, sentivamo di essere padroni di tutto, i dubbi erano la nostra forza. Ci chiudevamo in camera, e come bambini che afferrano le farfalle col retino acchiappavamo il significato della vita nei testi dei nostri artisti preferiti, ci sentivamo capiti da gente che non spesso non parlava neanche la nostra lingua, da persone così estranee ma al tempo stesso così vicine al nostro essere diversi.
In questo strano modo non eravamo più soli, e non temevamo nulla.
Poi arriva la consapevolezza dell’età, il terrore del futuro, il dolore della perdita. Cresciamo quando le persone a noi care ci lasciano, che sia un familiare, un amico, un idolo della nostra infanzia, la fine di un amore.
I sogni si infrangono come le finestre che da piccoli spaccavamo col pallone, intenti a giocare nel vialetto di casa. Le grida dei vicini iracondi sono ricordi lontani, ora le urla (interiori) sono le nostre.
Centelliniamo il dolore per ricavarne lezioni di vita che siano d’aiuto a non ripetere sempre gli stessi sbagli; evitando di non perdere la cazzimma tipica dei 20 anni, andiamo avanti, più consapevoli di prima, ma più stanchi.
Tutto questo e molto di più è racchiuso nel nuovo album dei Naftalina, pseudonimo del progetto solista di Peter Torelli, che ci regala Microgrammi Di Dolore, otto brani nei quali l’artista ci accompagna nei meandri della sua intimità emotiva più profonda.
Il gruppo ebbe molto successo nel ‘98 con l’album Non salti con me… T.V.T.B. e il singolo Se rimase al primo posto per otto settimane nella classifica di Radio Deejay.
Da qui la storia dei Naftalina si complica un poco, si sciolgono per poi tornare nel 2020 con l’album La Fine, che simboleggia il termine dell’epoca pop punk dei primi lavori, per entrare nella precarietà dell’età adulta.
Il suo timbro graffiante ma estremamente dolce e malinconico si lascia alle spalle la frivolezza della gioventù. Il sound che pervade l’album è indiscutibilmente più cupo. Le schitarrate pop punk lasciano il posto a violini, pianoforti e synth.
Richiamando ambientazioni filo-Romantiche, Peter, come un moderno eroe Byroniano, non si accontenta più del mondo circostante, delle imposizioni della società e, in un gioco di introspezione e ribellione verso la standardizzazione del sé, si abbandona alla ricerca del suo infinito.
L’irrazionalità della giovinezza è soggiogata dalla consapevolezza delle cose, dalla riscoperta della sensibilità, dei sentimenti e della propria spiritualità.
Un album molto personale, dove Peter ci dona la sua anima e la sua fragilità più pura.
Sembra facile è il suo urlo sospeso nello spazio, il suo abbandonarsi ad un destino che non è semplice da accettare con la fierezza di chi ha capito che lottare contro i mulini a vento è controproducente.
L’intro elettronico di Ok Replay ci conduce nella parte più complessa del suo spirito, e del suo personalissimo modo di reagire all’avvilimento attraverso l’elaborazione della perdita di fiducia e sul coraggio di rialzarsi.
La malinconia dei tempi che furono è sintetizzata in Betta 96, tributo alla grandissima Elisabetta Imelio, bassista dei Prozac+ e Sick Tamburo scomparsa prematuramente nel 2020, alla sua forza sul palco e alla sua indole instancabile. Questo omaggio è il pezzo più significativo dell album, ci ricorda quanta importanza hanno avuto i Prozac+ per la scena musicale italiana e soprattutto per Peter. A rendere il brano ancora più splenico le viole, i violini e il violoncello del Quartetto d’archi dell’orchestra sinfonica di Parma.
La delicatezza pervade tutti i brani, ma è lancinante in Un Altro Sogno Che e in Ti Sto Ascoltando, mentre Un’Ora In Più è una canzone d’amore dal finale sorprendentemente punk.
Questo album è il figlio di Peter del suo talento e del suo impegno; musica, testi, arrangiamenti, piano, voce, chitarra, basso e synth è tutto lavoro suo, in collaborazione con David Sabiu alla batteria e Riccardo Faedi alla chitarra acustica, batteria in Sembra facile Giulia “Juliette Ant” Formica, voce e cori Clarissa “Klari” Moragas.
Peter abbatte la mascolinità tossica con il suo nuovo lavoro, vestendo i panni di un uomo che non teme la tenerezza del suo essere, e grazie alla sua leggiadria riesce ad aprirci le porte delle sua anima, come solo un gentiluomo può fare.
Microgrammi di dolore con le sue sonorità ombrose riesce a mostrarci il cuore pulsante dell’artista, lontane dagli sfarzi leggeri della giovinezza, con una ritrovata emotività, ponendo al primo posto il cambiamento che solo il dolore può portare.
Un album colmo di dolore sì, ma anche di rinnovamento spirituale.
Naftalina
Microgrammi di Dolore
Supercharger Records
Marta Annesi